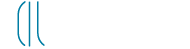UPR: su alcuni temi l’Italia non è disposta a migliorare i diritti
Nel quarto ciclo di Revisione Periodica Universale sostenuto a gennaio 2025, l’Italia è stato il terzo Paese per numero di raccomandazioni ricevute (340), dopo l’Egitto (343) e l’Iran (346).
Tra queste raccomandazioni provenienti da 123 Paesi, 295 sono state accettate, mentre le rimanenti solo ‘annotate’ o ‘parzialmente annotate’, il che significa che l’Italia non ha intenzione di mettere in atto azioni concrete per migliorare i diritti in queste aree, in quanto si ritiene che il quadro legislativo in vigore sia già sufficientemente adeguato.
L’ambasciatore italiano alle Nazioni Unite – Vincenzo Grassi – ha infatti fatto riferimento ai recenti sviluppi in materia di lotta alla violenza di genere, sottolineando il processo in corso per l’introduzione del reato di femminicidio e gli sforzi in atto del governo nell’elaborazione di un Piano Nazionale Strategico 2025-2027 per l’implementazione di misure di protezione e empowerment per donne vittime di violenza. Per quanto riguarda l’area della lotta contro la discriminazione e l’intolleranza, è stata posta l’attenzione sul nuovo Piano Nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza, elaborato in collaborazione con l’UNAR e recentemente approvato dal Ministero delle Pari Opportunità. Successivamente, l’attenzione è stata posta sul quadro normativo e strategico nell’area della disabilità e della migrazione.
Invece, l’Addendum pubblicato in risposta al report del Gruppo di Lavoro riporta i commenti e più estensivamente le motivazioni apportate dai Rappresentanti Permanenti della Delegazione italiana all’ONU rispetto alle raccomandazioni che non sono state formalmente accettate, motivazioni che purtroppo non rispecchiano le preoccupazioni e le criticità denunciate dalle organizzazioni che si occupano di diritti umani.
In particolare, il documento presenta le argomentazioni della Delegazione rispetto all’area della migrazione, del disarmo, dei diritti LGBT+, dell’autodeterminazione, della violenza di genere, delle relazioni diplomatiche e, infine, del contrasto ai discorsi d’odio e intolleranza nel nostro Paese.
Area migrazione
- Si afferma che i diritti delle persone migranti regolari e irregolari sono già adeguatamente garantiti nell’ordinamento;
- Si respinge la raccomandazione di ratificare la Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei loro familiari;
- Si afferma che le norme che negli ultimi due anni hanno gravemente ridotto lo spazio di operatività delle ONG SAR nel Mediterraneo, attraverso l’imposizione di pesanti sanzioni pecuniarie, l’imposizione di periodi di fermo amministrativo e l’assegnazione di SOP lontani, sono giustificate in quanto funzionali a un miglior coordinamento con le Autorità nazionali;
- Si afferma che il trattenimento amministrativo di persone migranti e richiedenti asilo all’interno di hotspot e CPR sia legittimo in quanto limitato nel tempo, con garanzie di assistenza, monitoraggio e tutela della salute;
- Si sottolinea il rispetto del principio di non-refoulement e le recenti misure adottate per migliorare le condizioni nei centri, in particolare a Lampedusa;
- Ci si astiene dall’adozione del Patto Globale sulle Migrazioni dell’ONU.
Area disarmo
- Si rifiuta il suggerimento di concludere nuovi trattati in materia di disarmo nucleare, in quanto il Trattato di Non-Proliferazione, in particolare all’Art 6, sia ritenuto sufficientemente adeguato all’obiettivo.
Area diritti LGBT+
- Non si ritiene necessario estendere i diritti delle coppie LGBT+ in unione civile sanciti dalla L. 76/2016, in quanto ritenuti paragonabili ai diritti delle coppie etero;
- Non si ritiene necessario agire a livello normativo riguardo la proibizione di “terapie di conversione” in quanto non fornite dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN);
- Non si ritiene necessario definire ulteriormente le modalità e circostanze di applicazione della chirurgia su minori intersex, in quanto ad ora circoscritte alla condizione di “necessità mediche”.
Area autodeterminazione
- Si ribadisce che l’Italia promuove un’educazione fondata sul rispetto nelle relazioni e sulla salute sessuale e riproduttiva, preferendo un linguaggio non ideologizzato e mal interpretabile, lasciando l’implementazione di programmi di educazione sessuale comprensiva (Comprehensive Sexuality Education) su base volontaria;
- Si considera adeguato il numero di strutture con obiettori di coscienza e il suo impatto nell’accesso a pratiche di IVG sicura;
- Si afferma che nel Paese le pratiche di punizione corporale nell’ambito educativo sono già vietate dalla legge.
Area violenza di genere
- Non si ritiene necessario intervenire a livello normativo per ridefinire il collegamento tra violenza sessuale e consenso, in quanto secondo la giurisprudenza italiana, la mancanza di consenso è sufficiente per configurare il reato di violenza sessuale, in linea con la Convenzione di Istanbul.
Area relazioni diplomatiche
- Si afferma che le relazioni diplomatiche dell’Italia con il regime afgano rientrino nel processo consensuale dell’ONU, ovvero circoscritte al processo di Doha.
Area discorsi d’odio e intolleranza
- Si rimanda alla responsabilità del Parlamento a legiferare rispetto a questo fenomeno, come sancito dalla Costituzione.
Alcune di queste motivazioni riportate nell’Addendum hanno suscitato molta preoccupazione e sconcerto da parte delle organizzazioni della società civile, soprattutto riguardo alla migrazione, i diritti della comunità LGBT+ e il contrasto ai discorsi d’odio e intolleranza nel Paese.
Analizzando le argomentazioni citate concernenti l’area migrazione, il lavoro di CILD e di tante altre organizzazioni fa emergere una realtà ben diversa rispetto alle informazioni riportate dalla Delegazione. In particolare, è evidente come le nuove norme che regolano le attività delle ONG SAR nel Mediterraneo abbiano come obiettivo reale quello di criminalizzare la solidarietà, ostacolando i salvataggi in mare e accusando sempre più persone di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Inoltre, nel report del Gruppo di Lavoro si legge che la Delegazione vanta l’efficacia degli accordi con Paesi di origine e di transito rispetto alle morti nel Mediterraneo, ignorando che nel 2024, oltre 2.200 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane partendo dai Paesi del Nordafrica, per un totale di oltre 31.000 vittime dal 2014.
Nel 2024 il sistema di accoglienza è stato definito “al collasso”. Il sovraffollamento e la riduzione estrema dei servizi di informazione e assistenza sono il sintomo innegabile di un sistema inadeguato e insufficiente a garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti e rifugiate.
Per quanto riguarda il sistema dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) italiani, CILD dal 2019 denuncia le condizioni degradanti in cui migliaia di persone sono detenute ogni anno, senza aver commesso alcun reato. In particolare, il difficile accesso al diritto di difesa, di informazione, alla salute; l’abuso nella somministrazione di psicofarmaci, e l’incertezza della durata dei trattenimenti, rendono i CPR dei “buchi neri”, ovvero un ambiente patogeno e svuotato di ogni diritto fondamentale.
Nel campo dei diritti LGBT+, l’associazione Arcigay ha riportato che l’Italia ha respinto 12 delle 19 raccomandazioni presentate sui temi di matrimonio egualitario, adozioni per coppie dello stesso sesso, riconoscimento di entrambi i genitori same-sex e tutela dei diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. Emerge quindi un quadro di forte resistenza rispetto all’ampliamento dei diritti della comunità LGBT+, in cui pare sempre più evidente la tendenza di Meloni a rimanere sul “modello Orbán”.
Infine, un’ulteriore area di policy problematica è quella che riguarda il contrasto ai discorsi d’odio e l’intolleranza. In Italia, il discorso d’odio e i contenuti online problematici sono in aumento, come confermato da Amnesty International Italia e approfondito nel sesto rapporto della Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI). I gruppi maggiormente colpiti da attacchi, sia online che offline, includono attivisti per i diritti sociali, persone migranti, persone emarginate e razzializzate, comunità LGBTQIA+, sindacati studenteschi, movimenti femministi, attivisti per il clima e ONG impegnate nel soccorso in mare. Purtroppo, molti di questi attacchi sono strumentalizzati da esponenti del governo per fini di propaganda. In particolare, le organizzazioni della società civile evidenziano una preoccupante normalizzazione del discorso d’odio, che si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione politica.
Il panorama giuridico italiano sul tema è caratterizzato da limiti legislativi e lacune nell’attuazione. La Legge Mancino (1993) e l’Articolo 604-bis del Codice Penale trattano le discriminazioni basate su etnia, nazionalità o religione. Tuttavia, queste leggi non offrono una protezione adeguata contro la discriminazione fondata su sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale. Di fronte a questa lacuna normativa, l’Italia non può rimandare la responsabilità al legislatore, quanto invece sarebbe auspicabile che la Delegazione accetti le raccomandazioni presentate a questo proposito e si impegni attivamente per innescare un processo di riforma mirato ad ampliare la normativa antidiscriminatoria per includere anche queste categorie non tutelate, che risulta bloccato nella Commissione Giustizia dal gennaio 2023.
Alla luce di questi elementi, sembrerebbe invece che l’Italia abbia accettato la raccomandazione di creare un’Istituzione Nazionale per i Diritti Umani, questione che CILD aveva anche sollevato in sede delle sessione preliminare dello UPR tenutasi a novembre a Ginevra, a partire dal contributo presentato lo scorso luglio insieme a Antigone, Cittadinanzattiva, 21 Luglio e Lunaria. Tuttavia, nella parte introduttiva dell’Addendum viene annotato che, per alcune raccomandazioni accettate, l’Italia non è in grado di stabilire un tempo limite per l’attuazione, lasciando quindi un dubbio sull’effettiva implementazione delle stesse nel breve periodo.
Aspetteremo dunque di poter valutare lo stato di implementazione generale delle raccomandazioni accettate all’interno del report intermedio che l’Italia ha promesso di sottoporre al Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2027.