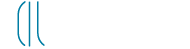Turchia, esiliati e incarcerati: repressione contro la libertà di pensiero
Mentre leggete questa frase 163 giornalisti sono detenuti nelle prigioni turche, impossibilitati a raccontare la repressione che Erdoğan ha fatto seguire al referendum. E mentre questa settimana sentirete parlare ancora del declino della libertà di stampa in Turchia, 5.182 accademici invece di fare ricerca staranno cercando lavoro, visto che i decreti governativi li hanno fatti licenziare dalle loro università.
La situazione in Turchia è veramente cupa, come gli osservatori internazionali e i corrispondenti stranieri hanno raccontato negli ultimi anni. Ma non ha ancora toccato il fondo; il popolo turco ha ancora molto da perdere, e ha ancora speranza, anche se poca, di invertire questo processo di decadenza, se riceverà presto il sostegno giusto.
#Turkey 155th out of 180 countries in #RSFindex: #journalism engulfed by unprecedented purge https://t.co/K9yLUGGgOE #FreeTurkeyMedia! pic.twitter.com/dV6UmNHZvn
— RSF_EECA (@RSF_EECA) 26 aprile 2017
Lo scorso fine settimana, nel suo rapporto annuale Freedom of the Press per il 2017, la Freedom House ha concordato con RSF, spiegando i nuovi livelli della repressione turca sui media, che usano lo stato di emergenza come pretesto: “Le autorità hanno chiuso una quantità di testate, obbligando migliaia di giornalisti e professionisti dei media ad abbandonare il loro lavoro, e hanno imposto restrizioni sui social media e sui siti web critici nei confronti del governo.” Ci sono ordini d’arresto per almeno altri 103 giornalisti, come la reporter Arzu Yıldız, che è stata anche privata della custodia dei figli nel maggio scorso, nell’ambito della condanna che ha ricevuto per aver raccontato una spedizione di armi dalla Turchia alla Siria. Yıldız oggi vive in esilio, come centinaia di altri giornalisti turchi. Ma il governo turco viola i suoi diritti anche in esilio, e fa la stessa cosa con Sevgi Akarçeşme, l’ex direttrice di Today’s Zaman, alla quale il governo turco ha annullato il passaporto mentre volava dal Belgio agli Stati Uniti.
#Turkey is the biggest loser in Press Freedom between 2012 & 2016 according to Freedom House. #Egypt & #Libya in the list. pic.twitter.com/krNMM68Htp
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 28 aprile 2017
Anche gli accademici turchi si trovano ad affrontare le stesse difficoltà, con i famigliari che subiscono punizioni collettive e vengono emarginati come “traditori” in una società sempre più polarizzata. Anche chi ha espresso critiche sta ricevendo minacce di morte, oltre a perdere posti di lavoro e docenze, mentre il paese si fa sempre più minaccioso. Gli appelli per la difesa della libertà degli accademici arrivati da tutto il mondo sono rimasti inascoltati in Turchia.
Quando gli accademici licenziati e i giornalisti incarcerati diventano la storia da raccontare, spesso non si pensa ai motivi per cui sono stati arrestati o cacciati. Ma la realtà è che, essendo loro le Cassandre della tormentata democrazia turca, ridurli al silenzio è diventato uno strumento per ottenere che nessun dissidente osi più parlare apertamente.
Nei primi anni 2000, i governi del partito AK sotto la guida di Erdoğan seguivano un programma liberal-riformista e avevano messo la Turchia su un percorso che avrebbe dovuto condurre all’entrata nella UE. Questo quando il paese – membro della Nato con una popolazione a maggioranza musulmana – veniva percepito e promosso come modello per il Medio Oriente. Eppure, alcuni segnali delle tendenze autoritarie di Erdoğan c’erano già. Nel 2008, uno dei quotidiani turchi di qualità, Sabah, e uno dei principali canali televisivi privati, ATV, vennero venduti a un’azienda gestita dal genero di Erdoğan attraverso un’asta statale. Gradualmente, fra intrecci familiari, interessi d’affari e scopi politici sono state create strutture proprietarie per i media in cui le linee editoriali pro-Erdoğan venivano (e vengono) premiate con maggiori appalti di stato nell’edilizia e nei progetti per le infrastrutture.
![[Fonte: RSF e il Media Ownership Monitor di Bianet, ricerca condotta da Elif İnce e Burcu Karakaş]](http://cild.eu/wp-content/uploads/2017/05/csm_45_EN_POLITICALAFFILIATIONS_TV_d5342841e7.png)
L’anno dopo, Erdoğan ha mirato ancora più in alto, bandendo Twitter e YouTube appena prima delle elezioni del marzo 2014, quando le prove della corruzione del governo si stavano diffondendo come un incendio sui social media. La censura totale delle notizie e dei commenti è stata resa possibile dagli emendamenti alla legge turca su Internet, che permettono a politici corrotti di nascondersi dietro ai processi per “diffamazione” per fare causa ai giornalisti.
Durante l’estate del 2015, altri emendamenti hanno fatto della “sicurezza nazionale” la parola d’ordine per bloccare i siti web di informazione e per emettere divieti di pubblicazione, mentre il conflitto curdo si intensificava nel sudest del paese, e la guerra in Siria traboccava al di qua del confine, con attentati nelle città turche. Il tentativo di colpo di stato dello scorso luglio non ha cambiato questo discorso sulla sicurezza, ma ha semmai aggiunto strumenti incontrollati all’arsenale governativo nella repressione della libertà di espressione, sia sui media tradizionali che online. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma di giornalismo indipendente P24, nel periodo seguito al tentato golpe il governo turco ha chiuso 5 agenzie di stampa, 20 riviste, 28 canali televisivi, 31 emittenti radio e 64 giornali, usando i poteri che gli derivano dalla promulgazione dello stato di emergenza.
I giornalisti turchi incarcerati, i media che sono stati chiusi e gli accademici licenziati vengono sostanzialmente tutti accusati dello stesso crimine, “terrorismo”, una definizione così ampia da servire solo a punire chi è critico nei confronti del governo. Nel rinvio a giudizio nei confronti di 18 dipendenti del quotidiano laico Cumhuriyet, i procuratori di stato hanno ripetutamente sostenuto che la linea editoriale del giornale, criticando la politica di sicurezza del governo, “sosteneva organizzazioni terroristiche” . E in tutti i decreti nati dallo stato di emergenza con cui sono stati epurati più di 134 mila dipendenti pubblici dopo il tentativo di colpo di stato di luglio, il governo insiste sulla stessa linea: “[i dipendenti pubblici elencati] sono membri di, o affiliati di, o collegati a organizzazioni terroristiche”. Eppure non vengono fornite né prove né l’accesso a processi equi, rendendo sia le epurazioni che gli arresti di massa incostituzionali, secondo l’organismo legale del Consiglio d’Europa. La realtà della Turchia è ormai al di là dell’ingiusto.
Alla fine dei conti, il problema della Turchia si riduce alla domanda che sta al centro di ogni sistema di governo: come controllare chi sta al potere bilanciando pesi e contrappesi?
Nel caso della Turchia, i media sono diventati la prima vittima, rendendo possibile far cadere anche tutti gli altri sistemi. Senza giornalisti a raccontare l’abuso di potere, la corruzione e la cattiva condotta; e senza intellettuali e accademici con una piattaforma da cui raccontare la minaccia dell’autoritarismo nella società, l’elettorato turco non ha avuto la possibilità di scegliere fra buon governo e cattivo governo. Invece, i media mainstream sono diventati strumenti di amplificazione della propaganda del partito di governo che vuole ridefinire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e hanno ignorato le critiche al potere. Le vittorie elettorali consecutive hanno dato a Erdoğan il sostegno legislativo per ritagliarsi leggi su misura, e queste hanno preparato la strada a una nuova schiera di giudici e procuratori di parte, utili a imporre la sua volontà. Perciò l’ultima vittima è il fallimento del sistema di pesi e contrappesi, lo stato di diritto, e questo segna la fine della Turchia come repubblica democratica. Il referendum che si è tenuto il 16 aprile ha solo dato un nuovo nome a questo effettivo cambio di regime che si stava preparando da un decennio.
La soluzione può soltanto ripartire da dove tutto ha cominciato ad andare storto, cioè dalla libertà di stampa; e l’ultima speranza della Turchia sta nelle mani di chi è sopravvissuto, dei giornalisti che hanno ancora il coraggio di dire la verità. Data l’attuale struttura dei media e la situazione legale, i media indipendenti turchi cercheranno ovviamente sostegno all’estero, nell’esilio. Guardando la Turchia dall’estero è facile cadere nella disperazione, ma le sue possibilità di sopravvivere stanno in gran parte nelle mani di chi può aiutare da lontano.
Efe Kerem Sözeri è il direttore Dekadans.co, fondato dopo che la testata indipendente per cui lavorava, Jiyan.org, è stata oscurata in Turchia. I suoi articoli sulla libertà di espressione e sulla censura in Turchia sono apparsi su P24 e Bianet in turco, e su The Daily Dot e Global Voices in inglese.
Traduzione di Marina Petrillo.