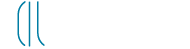Giornata mondiale del rifugiato. Quali Tutele? Ne parliamo con il CIR
Il 20 giugno è la giornata mondiale dei rifugiati e delle rifugiate. In un contesto globale sempre più complesso, costellato da disuguaglianze socio-economiche, frontiere securitarie, disastri ambientali dovuti al cambiamento climatico, guerre e ancora persecuzioni discriminatorie per via della propria provenienza, del genere o del proprio orientamento sessuale, essere persone rifugiate o migranti oggi comporta affrontare una miriade di ostacoli per riuscire a ottenere tutele e protezione adeguati. Ne abbiamo parlato con il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR): organizzazione umanitaria indipendente costituitasi nel 1990 in Italia, su iniziativa delle Nazioni Unite, che lavora per favorire l’accesso alla protezione delle persone che fuggono da guerre e persecuzioni e per contribuire a costruire condizioni di accoglienza e integrazione dignitose, nel pieno rispetto dei diritti umani.
1. Oggi è la giornata mondiale dei rifugiati e delle rifugiate. Innanzitutto vi chiediamo cosa significa essere persone rifugiate oggi?
Significa non solo affrontare il trauma dell’esilio, una condizione che comporta sempre l’abbandono della propria casa, della propria famiglia, delle proprie relazioni, del proprio quotidiano, ovvero di tutti quegli aspetti che formano l’identità stessa delle persone. Ma significa anche cercare di ottenere protezione in un mondo, questo vale in particolar modo per l’Europa, che sta diventando sempre più ostile nei confronti dei rifugiati. E quindi oltre al dolore della fuga, i rifugiati sono costretti a superare innumerevoli ostacoli sia per ottenere il necessario riconoscimento del proprio status, sia per potersi inserire nella società di accoglienza. E spesso sono circondati da contesti inospitali.
2. Quali sono i maggiori ostacoli riscontrati dalle persone rifugiate che, seppur con molteplici difficoltà, riescono a raggiungere l’Europa?
Credo che il primo grande ostacolo sia, purtroppo, ancora raggiungere l’Europa. Le rotte che portano verso l’Italia e l’Europa, ovvero quelle che attraversano il Mediterraneo e la Rotta Balcanica che parte dalla Turchia, sono estremamente pericolose. I rifugiati sono esposti a violenze, rischiano la vita e i loro diritti sono costantemente calpestati. Il Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più letale al mondo. E in questi giorni abbiamo visto quanto possa essere pericoloso anche il viaggio che attraversa il Mare Ionio.
Una volta giunti in Italia e in Europa purtroppo le difficoltà non sono ancora finite. Uno degli ostacoli maggiori è l’accesso alla protezione, ovvero riuscire a chiedere asilo e ottenere, attraverso una procedura equa, un riconoscimento del proprio diritto di essere protetto. Anche ottenere un’accoglienza adeguata rimane una difficoltà forte, almeno nel nostro Paese. Le condizioni di accoglienza sono in molti casi indignitose e anche avere un posto in questi centri è un percorso a ostacoli. Infine, un ultimo ma davvero grave problema che i rifugiati sono costretti a fronteggiare è la possibilità di realizzare percorsi positivi di inclusione. Ovvero essere messi nelle condizioni di avere una formazione adeguata, un lavoro in linea con le proprie competenze, un accesso a cure mediche adeguate, una vita sociale e un alloggio. Purtroppo, sono molte le storie che raccogliamo di rifugiati che lavorano in condizioni di grave sfruttamento, pensiamo a esempio a quanti sono vittime del caporalato in agricoltura, o che hanno difficoltà a trovare un alloggio regolare. Vi è una fortissima discriminazione nei confronti dei migranti in generale nel mercato immobiliare privato, spesso ottenere un contratto di affitto regolare e una casa dignitosa è impossibile.
3. In che modo le politiche migratorie dei vari paesi influiscono sulla vita dei rifugiati e cosa si potrebbe fare per renderle più umane e inclusive?
Le politiche migratorie influiscono enormemente sulla vita dei rifugiati. Perché definiscono il quadro dei diritti loro riconosciuti e del modo in cui, tali diritti, possono essere ottenuti. Non solo, le politiche e il modo in cui la società si dispone nei confronti dei rifugiati sono strettamente correlati. Politiche restrittive corrispondono a società meno accoglienti, non so quale sia l’ordine causale, ma vi è una stretta correlazione. E le politiche che in Italia e in Europa stiamo implementando vanno in un’unica direzione: restringere lo spazio di protezione e i diritti dei rifugiati. In modo drammatico. Pensiamo all’accordo con la Turchia, quello con la Libia o la Tunisia. O il Protocollo con l’Albania. O la feroce lotta fatta contro le ONG che soccorrono i migranti in mare. Non solo hanno avuto e hanno effetti devastanti per le vite di quanti subiscono gli effetti di tali accordi, ma queste politiche hanno contribuito a creare una società insensibile al dolore dei rifugiati. Siamo divenuti insofferenti ai loro diritti. Se pensiamo alla reazione che abbiamo avuto alla drammatica foto del piccolo Alan Kurdi, con il movimento di accoglienza che ha generato in Germania e che poi si è diffuso ampiamente nella società civile di molti Paesi, e la confrontiamo all’indifferenza totale con la quale abbiamo guardato alla foto di Fati Dosso e Marie, la povera mamma e bambina morte nel deserto Tunisino, capiamo bene quanto le politiche e la nostra società siano cambiate.
4. Nello specifico del nostro paese, qual è l’impatto delle attuali politiche migratorie italiane – dalla Legge Bossi Fini all’attuale Decreto Piantedosi – sulla vita delle persone rifugiate o migranti?
Le attuali politiche stanno generando, e lo faranno ancor più in futuro, un impatto drammatico sulla vita dei migranti e rifugiati. Se guardiamo solo agli ultimi due anni abbiamo avuto 4 decreti legislativi e il famigerato Protocollo con l’Abania. Questi decreti, le cui radici erano già nei Decreti Salvini e che tradiscono una vera e propria bulimia legislativa, legiferano su aspetti diversi, ma sono tutti accomunati da uno scopo: rendere più difficile l’accesso alla protezione e restringere i diritti. Sono molte, e negative, le novità introdotte.
È stata estesa la procedura accelerata a tutti coloro che provengono da Paesi di origine sicuri. E la lista dei paesi di origine sicuri è stata ampliata e ora include, tra gli altri, anche Bangladesh, Egitto, Tunisia, Ghana, Nigeria, Camerun. Paesi di origine da cui proviene la maggior parte delle persone che arrivano in Italia. Questo si traduce in una procedura che ha garanzie molto inferiori rispetto a quella ordinaria: vi è un’inversione dell’onere della prova che ricade ora sulla persona che richiede asilo e vengono dimezzati i tempi per fare ricorso contro una decisione negativa. Per chi è in queste procedure è molto difficile vedersi riconoscere una protezione. È stato poi introdotto per la prima volta nel nostro Paese il trattenimento per i richiedenti asilo cui si applica la procedura di frontiera accelerata: le persone che chiederanno asilo in frontiera e vengono da paesi considerati sicuri potranno essere detenute se non consegneranno i passaporti o potranno dimostrare delle garanzie finanziarie. È importante sottolineare che il Tribunale di Catania si è espresso a ottobre contro la detenzione di richiedenti asilo tunisini, definendo dei limiti alle possibilità di trattenimento per chi chiede protezione. Oltre queste riforme, che possono generare potenzialmente conseguenze drammatiche se guardiamo alla composizione dei flussi migratori verso l’Italia, ci sono una serie di ulteriori aspetti che stanno avendo un grave impatto sulla vita di migranti e rifugiati. È stata estesa la detenzione amministrativa nei famigerati CPR a 18 mesi per i migranti in attesa di espulsione. I diritti dei richiedenti asilo sono diminuiti: chi chiede protezione ora può essere accolto, a meno che sia vulnerabile, solamente nei centri governatici e nei CAS. Centri da cui sono stati eliminati servizi essenziali come l’assistenza legale, quella psicologica e i corsi di lingua italiana. In più, in momenti di crisi, tali centri possono essere sovraffollati del 100% in più rispetto alle loro capacità. Il Decreto Salvini ha eliminato la protezione umanitaria, inserendo la ben più limitata protezione speciale e diverse forme di protezione per casi speciali. L’ampiezza di tali forme di protezione è stata ulteriormente ristretta dal decreto Cutro e sono state rese non convertibili. Questo vuol dire che le persone che hanno queste protezioni potranno stare in Italia per due, tre anni, ma che hanno una data di scadenza sopra. Non potranno infatti, dopo un certo periodo, più rinnovare tali permessi di soggiorno o convertirli. Questo aspetto creerà delle situazioni davvero drammatiche. Infine, pensiamo all’impatto di queste riforme sui minori che arrivano in Italia non accompagnati, da soli. Ora potranno essere accolti nei centri per adulti dai 16 anni in su, per un massimo di 90 giorni e in ambienti separati. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha già condannato l’Italia per un caso analogo. Mettere dei ragazzi e delle ragazze molto giovani in condizioni di accoglienza inadeguate può avere un impatto devastante sia sul percorso di protezione che sulle loro capacità di integrazione.
5. Nonostante sia una delle tutele fondamentali inserite all’interno delle più importanti convenzioni internazionali (Ginevra, CEDU), quanto è davvero garantito il diritto di asilo in Italia?
Il diritto d’asilo in Italia in questo momento non sta godendo di buona salute, purtroppo. Oltre alle restrizioni introdotte di cui abbiamo parlato, abbiamo un sistema asilo che versa in condizioni gravissime. La possibilità di chiedere asilo dal territorio, ovvero andando spontaneamente alle Questure e non in frontiera, è gravemente compromessa . In molte città, penso tra le altre a Milano e Roma, anche solo accedere fisicamente all’ufficio della questura è impossibile. Non solo, una volta manifestata la volontà di richiedere asilo l’appuntamento per formalizzare la domanda di protezione – ovvero il momento in cui si è considerati richiedenti asilo e quindi scattano tutti i diritti riconosciuti come accoglienza, accesso al servizio sanitario, lavoro – è di molti mesi. Abbiamo seguito persone a cui tale appuntamento è stato dato anche dopo 11 mesi. Un tempo in cui la persona non ha nulla ed è destituita di tutti i più elementari diritti. Inoltre, il sistema di accoglienza è sempre più sbilanciato verso i centri governativi e straordinari, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di fruizione di diritti e possibilità di inclusione.
6. Quali soluzioni per delle politiche migratorie che siano davvero aperte, inclusive e antirazziste?
Sarebbe bello avere una risposta definitiva a questa domanda. Credo che politiche aperte inclusive e antirazziste possano nascere solamente all’interno di una società inclusiva, aperta e antirazzista. Da questo punto di vista è una nostra responsabilità costruire tali politiche, con le scelte che facciamo tutti i giorni e un impegno a trasformare quanto abbiamo attorno a noi. Dobbiamo sentirci responsabili e non possiamo più guardare con indifferenza a quello che succede a chi arriva nel nostro Paese.
7. Ci sono esempi di esperienze positive, storie di successo, che avete vissuto lavorando nel campo della tutela delle persone migranti o rifugiate? Come queste esperienze hanno influenzato il vostro impegno nel campo dei diritti umani?
Fortunatamente sono tante le storie positive che abbiamo vissuto e che abbiamo contribuito a costruire. Penso ai ricongiungimenti fatti con i minori stranieri che sono arrivati in Friuli Venezia Giulia da soli, bambini anche di 10 anni, e che grazie al nostro impegno hanno riabbracciato i genitori che sono riusciti ad arrivare in modo legale e sicuro. O alle rifugiate e ai rifugiati che grazie alle loro competenze e alle opportunità che siamo riusciti a dare loro, hanno potuto reinserirsi nelle professioni che hanno lasciato. Lavori qualificati e pagati in modo equo. Non solo, lavori che hanno restituito a queste persone un’immagine di sé piena, rimettendo in comunicazione il passato e il presente e ricucendo in parte lo strappo che l’esilio provoca.
Foto copertina: Gustave Deghilage (CC BY-NC-ND 2.0).