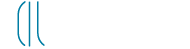Raccontare i CPR. Intervista a NAGA e IrpiMedia su “Dietro quella porta”
di Irene Proietto e Arianna Egle Ventre
A gennaio è uscito il podcast “Dietro quella porta” realizzato dalla testata di giornalismo indipendente ‘IrpiMedia’ insieme all’associazione Naga e prodotto da Intreccimedia. Nel corso delle quattro puntate da 20 minuti l’esperienza dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) viene raccontata attraverso la storia di quattro persone che hanno vissuto il trattenimento. Le loro voci si intrecciano ad altre testimonianze di persone a loro vicine che hanno vissuto il CPR come riflesso, oltre che di quelle persone che quotidianamente denunciano il sistema della detenzione amministrativa.
In occasione della sua pubblicazione abbiamo intervistato Dario Paladini, giornalista di IrpiMedia e ideatore del podcast e Laura Balboni, volontaria dello sportello legale del Naga, organizzazione che dal 1987 è impegnata nell’assistenza socio legale delle persone migranti sul territorio di Milano.
1. Come nasce l’idea del podcast?
Dario Paladini, giornalista di IrpiMedia:
L’idea del podcast nasce dal rapporto “Dietro quella porta” realizzato dal Naga e dalla Rete ‘Mai più lager- NO ai CPR’. Ci siamo chiesti insieme come raccontare i CPR: vediamo spesso video di denuncia realizzati dai trattenuti nel CPR dove sentiamo grida di disperazione o vediamo gesti di autolesionismo. Questo tipo di video sono importanti e devono essere diffusi, però noi volevamo offrire un tipo di racconto diverso da ciò che già esiste.
Non sappiamo nulla di queste persone, di chi fossero prima di essere rinchiuse, che vita facessero, quali sogni, speranze e quali rapporti di amicizia e di parentela avessero, come e perché fosse avvenuto il fermo. Si chiamano Alexander, Fued, Mohamed e Saif; ciascuno ha una sua individualità. Abbiamo voluto restituire quella personalità e unicità che nel CPR viene annullata. Siamo andati a cercarli da uomini liberi, quindi liberi di parlare e di esprimersi lontani da ogni tipo di vincolo che gli pone il CPR.
La domanda che guida il podcast si interroga su quale racconto possa restituire dignità e umanità a chi è trattenuto nel CPR.
2. Qual è stata la prima reazione di Naga alla proposta di realizzare un podcast?
Laura Balboni, volontaria NAGA
Inizialmente eravamo un po’ titubanti per l’esposizione di persone che sono in una condizione di fragilità, sia derivanti dal passaggio per i CPR, sia frutto dell’esperienza post CPR. Molte persone infatti rimangono in una condizione di irregolarità ed è difficile andare a indagare su questioni psicologicamente difficili che non si sono neanche risolte.
La difficoltà di condividere l’esperienza del CPR è data dal fatto che spesso le persone che sono state trattenute provano quel senso di colpa indotto dai media, dall’opinione pubblica e dalla propaganda. Diviene una colpa non avere documenti, ed essere non regolari. Spesso sentono di avere una responsabilità in quello che gli è successo.
Tuttavia dopo aver deciso di partecipare al podcast abbiamo visto che un buon numero di persone ha molta voglia di condividere la propria storia.
4. Quali sono state le difficoltà nel raccontare i CPR?
Laura Balboni, volontaria NAGA
Una difficoltà è certamente sapere come narrare i CPR da un punto di vista umano. Le persone trattenute subiscono dei processi di vittimizzazione secondaria. Dar voce a queste esperienze implica confrontarsi con la criminalizzazione che tocca anche chi non ha commesso reati. Per questo il podcast è un primo passettino ma io spero davvero ci siano anche altri progetti che portino avanti una nuova narrazione delle persone che entrano in CPR.
5. Vi siete scontrati con l’opacità del sistema CPR durante il lavoro?
Dario Paladini, giornalista IrpiMedia:
Devo premettere che per la parte di documentazione mi sono basato sull’enorme lavoro di ricerca che ha fatto Naga, IrpiMedia e altre testate e associazioni. Un lavoro che è frutto di anni, oltre che di numerosi accessi agli atti negati. Un elemento critico del CPR è infatti proprio la poca trasparenza.
Prendiamo per esempio il tema col quale noi chiudiamo il podcast; le morti nei CPR. Quante sono le persone che sono morte all’interno dei CPR? Il Naga ha dovuto fare ben tre volte l’accesso agli atti. All’inizio veniva risposto che non c’erano dati sulle persone decedute nei Centri di permanenza per il rimpatrio. Poi, a seguito del costante impegno nell’ottenere questa informazione, questi nomi sono venuti fuori. Eppure apparivano cinque casi in cui il nome era ignoto. Era registrata la nazionalità, l’età e il luogo del decesso, ma non il nome e cognome. Questo è veramente disumano. Il fatto che una persona muoia e non venga registrato il nome, ci riporta al discorso iniziale. Il CPR disumanizza le persone proprio per come è strutturato. La possibilità che il decesso di qualcuno rimanga senza nome evidenzia un problema di trasparenza. La trasparenza è garantita anche attraverso una lista completa di nomi di chi è trattenuto: nessuno in un Paese democratico può essere rinchiuso senza che non sia registrato con nome e cognome a garanzia che questa persona non sparirà mai. Il fatto che noi abbiamo un elenco di morti senza nome dice molto su questa trasparenza.
La democrazia si basa sulla trasparenza.
5. Nel podcast parlate del percorso per intero; del prima, del durante e del dopo. L’esperienza della detenzione viene inserita in un contesto più ampio. Perché questa scelta?
Laura Balboni, volontaria NAGA
L’obiettivo principale era narrativo: le quattro storie che si sentono permettono di entrare in confidenza con delle persone che hanno un loro vissuto che va al di là del CPR; sono persone che attraversano un periodo di estrema difficoltà e di ingiustizia. Senza aggravare una narrazione solo di disperazione abbiamo sentito l’esigenza di umanizzare questi racconti. Da qui la scelta di intervistare anche i parenti dal momento che questa detenzione coinvolge sicuramente in primis le persone che sono trattenute, ma anche i familiari. Ci premeva parlare del “prima” per avvicinarci a queste persone, capire chi sono, cosa facevano, cosa rappresenta questa interruzione della loro ordinarietà.
In merito al “dopo”: già che ci sia un “dopo” nel territorio italiano, implica il fatto che i CPR non funzionano e che non abbiano senso di esistere. Il CPR non risolve alcun problema, ne crea altri: non permette alle persone di continuare la loro vita e di occuparsi della loro regolarizzazione sul territorio perché i loro percorsi vengono interrotti bruscamente. Sono in un limbo totale anche dopo l’esperienza del CPR, nonostante la libertà di circolare sul territorio. Incontrano molti ostacoli, a meno che non ci sia qualcuno che ponga fine a quei cavilli giudiziari e procedurali che ne impediscono la regolarizzazione.
6. Come ha impattato concretamente il CPR nella vita delle persone che avete intervistato?
Dario Paladini, giornalista IrpiMedia:
L’esperienza del trattenimento in un CPR è traumatica. Chi si trova in un CPR è privato della sua libertà per la sua situazione di irregolarità e non per aver commesso un reato. In più il trattenimento dura per un tempo indefinito: il massimo è di 18 mesi, ma nessuna persona trattenuta al momento dell’ingresso sa con precisione quanto dovrà rimanere nella struttura. Nel CPR il giudice di pace rinnova periodicamente il trattenimento a seconda delle situazioni, ma nel frattempo potresti essere deportato; ogni notte vivi la paura che potrebbero arrivare gli agenti di polizia per prelevarti e metterti su un aereo.
Le persone che ho intervistato erano persone che da pochi mesi avevano vissuto questa esperienza. Era chiara la ferita ancora fresca di questo trauma vissuto con tutto quello che comporta. Ogni volta che escono di casa vivono ancora la continua paura di essere fermati, di ritrovarsi di nuovo in quel buco nero che impatta sulla quotidianità.
Fued, proveniente dalla Tunisia, aveva un lavoro quando è stato trattenuto, ma lo ha perso. Il fermo è avvenuto in questura: lui aveva chiesto mezza giornata di permesso dal lavoro per risolvere la questione del ricorso rispetto al diniego del suo permesso di soggiorno. E invece il giorno dopo non si presenta al lavoro perché lo hanno trattenuto in un CPR.
Prima, dopo e durante la vita ristretta nel CPR ti senti assolutamente vulnerabile. Anche una volta rilasciato, se rilasciato, continui a vivere con la paura di essere fermato e di poter di nuovo vivere quell’esperienza drammatica o di essere rispedito in un paese nel quale non vuoi tornare.
Alexander, un’altra voce del podcast, è arrivato in Italia quando aveva tre anni e non sa la lingua del Paese di cui la sua famiglia è originaria nei Balcani. Se lui dovesse essere rimpatriato non solo non saprebbe la lingua ma non avrebbe nessun legame nel Paese perché tutta la famiglia vive in Italia.
Un’altra storia è quella di Muhammad, una storia paradossale. Lui è stato rimpatriato in Egitto eppure è potuto tornare in Italia con un volo regolare perché l’avvocato ha fatto ricorso al TAR ed è riuscito a dimostrare che era stato rimpatriato in maniera illegittima. Chiaro, questa è un’eccezione, molti altri una volta nel loro Paese non hanno altra scelta che rimanere lì. Ma anche coloro che vengono rilasciati e rimangono in Italia, sono abbandonati a se stessi .