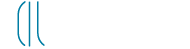Rifugiati ambientali, l’emergenza (ignorata) del secolo
Sabato 24 settembre, a Milano, a Palazzo Reale, di fronte a un folto e attento pubblico, si è tenuto il Convegno Internazionale: “Il secolo dei rifugiati ambientali”, promosso dalla parlamentare europea (gruppo GUE/NGL) Barbara Spinelli. Tra gli ospiti, eurodeputati, accademici, esponenti dell’associazionismo e della società civile, con un nutrito gruppo di milanesi a fare gli onori di casa.
Come ammesso dalla stessa Spinelli e da Vittorio Agnoletto in apertura lavori, il titolo era volutamente provocatorio e inevitabilmente pruriginoso: ad EXPO 2015 – salvare il pianeta, energie per la vita, nella Carta di Milano, non c’era spazio per loro.
“Loro” sono appunto i 200-250 milioni di rifugiati ambientali (6 milioni all’anno in media) che IOM e UNHCR prevedono vagare nel mondo entro il 2050. Da quanto emerso nei lavori congressuali la difficoltà maggiore consiste nel capire chi sono, perché anche gli esperti, vuoi per complessità giuridiche, politiche o culturali faticano a motivare il fenomeno.
Ecco alcuni aspetti chiave emersi nel dibattito.
Andare oltre le classificazioni, per il riconoscimento legale degli ecomigranti
Innanzitutto la richiesta di un riconoscimento legale esplicito degli ecomigranti, come sono anche chiamati, è ampiamente condivisa: la Convenzione di Ginevra sul diritto d’asilo del 1951 non concede loro lo status di rifugiato, titolo che spetta a chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese.
Appurato che neanche gli accordi successivi, dal Protocollo del 1967 alle Dichiarazioni di Addis Abeba e Cartagena, rispettivamente 1969 e 1984, contemplano la fattispecie, e che comunque non sono vincolanti per gli Stati (per la solita discrepanza formale tra firma e ratifica), alcuni degli studiosi intervenuti, tra cui Benoit Mayer e Roger Zetter, hanno voluto approfondire una questione, la definizione appunto, che rischiava un trattamento superficiale.
Entrambi condannavano la separazione tra rifugiati, verso cui gli stati hanno obblighi giuridici, e migranti forzati (forced migrants), verso i quali pendono soltanto obblighi morali; biasimano il fatto che i rifugiati ambientali appartengano ai secondi, al pari dei migranti economici, e non ai primi; ma, faceva notare Mayer, assistant professor all’Università cinese di Hong Kong, che imporre agli stati un obbligo di proteggere i rifugiati, con o senza ecomigrants, dà il diritto agli stati stessi di non proteggere i rifugiati ambientali.
Il messaggio è chiaro: così facendo sbagliamo tanto quanto i legislatori; finiamo per classificare i migranti, fare il tifo per gli uni o per gli altri dimenticando che come uomini godiamo tutti di diritti umani.
A maggior ragione, rimarcava il professor Zetter, ex Direttore del Refugees Study Centre di Oxford, cogliendo un’altra sfumatura che nell’oggi della paura passerebbe inosservata, poiché i rifugiati ambientali sono in stragrande maggioranza “internally displaced people” (soggetti ai Guiding Principles on International Displacement” del 1998), sfollati interni ai loro Paesi, dislocati e ricollocati coi cambiamenti climatici e i disastri ambientali che fungono da “drivers” – in altre parole, “moltiplicatori”, “acceleratori” – di macro e micro fattori economici, sociali, politici, culturali ecc.

Antropocene e migrazioni di sopravvivenza
La puntualizzazione per cui ambientale non significa ambientalista o similari ma soggetto a spostamento forzato ha convinto un po’ tutti.
Ebbene non ci sono convenzioni da riscrivere, ci sono principi e leggi da applicare, c’è consapevolezza che, direbbe Alexander Betts, l’unica migrazione è una migrazione di sopravvivenza (survival migration) e che non possiamo distinguerli poiché le ragioni del partire sono molteplici e complementari.
Se poi legalisticamente ci atteniamo alla norma, ricordava Gemenne, riprendendo in qualche modo il tono amaro del titolo, i migranti ambientali sono vittime di persecuzioni di cui noi siamo politicamente responsabili.
A questo mentre appare opportuno menzionare una seconda mancanza, empaticamente più sentita del vuoto legislativo: quella di una coerenza politica della cosiddetta Comunità Internazionale.
È stato Francois Gemenne, direttore del programma Politiche della Terra a SciencesPo, ad assumersi la responsabilità di introdurre un argomento troppo sovente facile a populismi e paternalismi, con maturità scientifica, anzi accademica.
Prendendo a prestito dal biologo Eugene Stoermer il termine Antropocene, nome della nostra epoca geologica, ha preso posizione, ricordando che gli umani non possono più imputare ad altri fattori i cambiamenti della terra, del territorio o del clima che ora dipendono direttamente da loro; coniando poi il termine Oligantropocene, ha fatto un altro passo avanti, specificando che disastri ambientali vari non sono colpa di tutti gli uomini indistintamente, ma di una piccola parte ricca di mondo, purtroppo la nostra, che peraltro scarica i propri rischi sui poveri (Giuseppe De Marzo, con un’altra delle espressioni accese che hanno colorito la conferenza, ha parlato di “razzismo ambientale”).
Possiamo comprendere il passaggio con un caso particolare, esemplificativo e generalizzabile: in un periodo in cui gli accordi commerciali tra paesi ricchi, come il CETA tra Canada e Unione Europea o il TTIP tra UE e Stati Uniti, non decollano per dei protezionismi nazionali crescenti, stanno prendendo quota gli EPA, accordi liberisti dell’Europa con paesi di Africa, Caraibi e Pacifico, ma soprattutto africani. Secondo tali accordi, ancora bilaterali, gli stati africani sono costretti a rimuovere i dazi doganali, mentre quelli europei sovvenzionano le nostre multinazionali per vendere sul loro mercato a prezzi bassissimi, distruggendo una economia locale prima autosufficiente e disgregando popoli un tempo uniti.
Salvo vendere qualche aiuto internazionale (1.8 miliardi all’Africa sono poca roba rispetto ai 6 alla Turchia!) o qualche area protetta (magari espropriandola agli indigeni che l’hanno conservata per secoli), pure a buon prezzo.
Se pensiamo che si stimano in 1000 miliardi i soldi persi dai paesi africani per elusione ed evasione fiscale delle multinazionali europee, capiamo che qualcosa non va.
Quel qualcosa riguarda anche il land-grabbing, operazione con cui pochi potenti, con gli stessi accordi commerciali di cui sopra, stanno acquistando terreni nel continente nero e non solo (almeno 87 milioni di ettari) o il water-grabbing, o altre cause concatenate: risultante economica del vivere in carestia e siccità, in scarsità di risorse, è guerreggiare per la loro allocazione: chi vince resta, chi perde parte iniziando processi di villaggizzazione, quindi urbanesimo (perché gli ecomigrants, ribadiamolo, sono sfollati interni) e solo infine emigrazione verso il vecchio continente. Dopo le due guerre mondiali 111 conflitti per cause umane-ambientali sono nati così, Maghreb e Medio Oriente per nominarne alcuni.
Il futuro dell’Europa
Ma alla base di ogni riflessione politica e giuridica, per cui degna conclusione a questa embrionale valutazione, c’è un problema sollevato da molti convegnisti tra cui l’organizzatrice Barbara Spinelli ad inizio lavori, una grossa mancanza culturale. Essa affonda le radici nel campo minato dell’Unione Europea: non essere unione.
Incapace di adottare una politica di asilo comune, incapace di ricollocare i richiedenti asilo nei 27 (28?) paesi dato che solo 6 paesi hanno accettato le quote (per cui si è andati al voto domenica 2 ottobre in Ungheria), ma capacissima di spendere, sostengono dei ricercatori svedesi, 13 miliardi di euro per murare le frontiere. Ebbene sì, nel border management non c’è crisi.
Approfondimento a cura di Giovanni Brusaporco.
Immagine di copertina: vladsokhin.