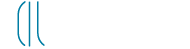Il crimine di parlare. Libertà di espressione e diritto penale in Europa
Il Consiglio d’Europa ha pubblicato una nuova guida nella quale mette in guardia contro il crescente ricorso al diritto penale che, utilizzato per giustificare la tutela di altri diritti e interessi, rischia invece di restringere la libertà di espressione e il pluralismo delle opinioni.
Un giornalista in un’aula di tribunale, lo sguardo teso. Non ha ucciso, non ha rubato. Sta rispondendo di un articolo scomodo.
Si tratta di un’immagine tutt’altro che di fantasia, che può sembrare lontana, eppure succede ogni volta che la parola diventa un crimine.
La libertà di espressione … si applica non solo alle “informazioni” o alle “idee” che sono accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, scioccano o disturbano lo Stato o qualsiasi settore della popolazione. Queste sono le esigenze di quel pluralismo, tolleranza e apertura mentale senza i quali non esiste una “società democratica”.
Così scriveva la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel dicembre 1976, pronunciandosi nel caso Handyside v. the United Kingdom, e con queste parole la Division for Cooperation on Freedom of Expression del Consiglio d’Europa apre il rapporto che ha appena pubblicato dal titolo eloquente: Limiting the Use of Criminal Law to Restrict Freedom of Expression. L’idea di fondo è chiara: il diritto penale deve essere usato con limitazione e attenzione, uno strumento estremo da richiamare solo quando ci sono minacce concrete e gravi, non quando un politico o un’azienda capace di influenza sulla sfera pubblica si sentono offese da un editoriale o colpite da un’inchiesta.
Perché la differenza non è solo giuridica, è culturale e democratica. Trasformare la parola in reato produce quello che la Corte europea dei diritti dell’uomo definisce da decenni il chilling effect, l’effetto raggelante. In altre parole: non serve il carcere, basta la minaccia di un processo per scoraggiare giornalisti, attivisti, avvocati dal dire ciò che pensano.
E non si tratta solo dell’entità della pena o della sanzione, come sempre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte riconosciuto.
Ad esempio nel caso Şener v. Turkey, la Corte scriveva che anche una condanna sospesa “ha l’effetto di restringere il lavoro dell’editore e ridurre la sua capacità di offrire al pubblico opinioni che hanno il loro posto in un dibattito di interesse generale”. Una spada di Damocle che pende sul capo di chi scrive.
O nel caso Brasilier v. France, quando i giudici arrivarono a dire che “sebbene la condanna a un franco simbolico sia moderata quanto più possibile, non è sufficiente, di per sé, a giustificare l’ingerenza con il diritto alla libertà di espressione”. Anche un euro, insomma, è troppo quando si tratta di idee.
La guida del Consiglio d’Europa individua cinque aree dove il rischio di abuso è maggiore:
- hate speech, che va punito solo se incita concretamente a violenza o discriminazione;
- diffamazione e ingiuria, dove si raccomanda la decriminalizzazione e il ricorso a strumenti civili;
- informazioni riservate, che vanno bilanciate con l’interesse pubblico alla trasparenza;
- sicurezza nazionale, spesso usata come pretesto per imbavagliare le opposizioni;
- disinformazione, per cui la via penale è inefficace e sproporzionata.
Il filo rosso è sempre lo stesso: chiarezza, proporzionalità, moderazione. Perché leggi vaghe sull’“offesa” o sul “decoro” aprono la porta a interpretazioni arbitrarie e condanne motivate politicamente che di fatto possono limitare la libertà di espressione, con un effetto degradante anche per la tenuta democratica dei paesi.
A questo proposito, a destare preoccupazione c’è il fatto che, secondo i dati raccolti dalla piattaforma del Consiglio d’Europa sulla sicurezza dei giornalisti, i casi di detenzione e incarcerazione di giornalisti siano aumentati notevolmente dal 2019.
Ed è qui che il discorso si collega a un’altra minaccia crescente: le SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation, per cui l’Italia non ha ancora una legge, pur avendone bisogno. Cause intentate non per vincere, ma per logorare, zittire, intimidire. Spesso sono azioni civili, ma il rischio è che anche lo strumento penale diventi una SLAPP potenziata, con effetti ancora più devastanti. Un procedimento penale aperto, anche se finisce con un’assoluzione, lascia cicatrici: costi, tempo, reputazione, e soprattutto paura.
La Corte EDU lo ha detto chiaramente: persino il solo avvio di un’indagine può avere un effetto dissuasivo. Nel caso Altuğ Taner Akçam v. Turkey, che il rapporto del Consiglio d’Europa richiama, il rischio concreto di essere indagati per “denigrazione della turchicità” era già sufficiente a limitare la libertà di parola.
Per questo, il Consiglio d’Europa ribadisce che il carcere per reati d’opinione è ammissibile solo in casi eccezionali — come l’incitamento all’odio violento — e che persino le sanzioni più lievi vanno valutate con cautela. In Italia, nonostante l’impegno di addetti ai lavori, organizzazioni della società civile e le condanne della stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la diffamazione è ancora un reato per cui si rischia il carcere e ogni ipotesi di riforma viene respinta o derubricata a “non prioritaria”.
Alla fine, la domanda è semplice: vogliamo una società che punisce le parole o una che le discute?
La democrazia si misura anche così: dallo spazio che lascia alle voci critiche, a chi disturba, a chi dice cose che non vogliamo sentire. Punire la parola non ci rende più sicuri. Ci rende solo più silenziosi.
Foto di Gayatri Malhotra su Unsplash