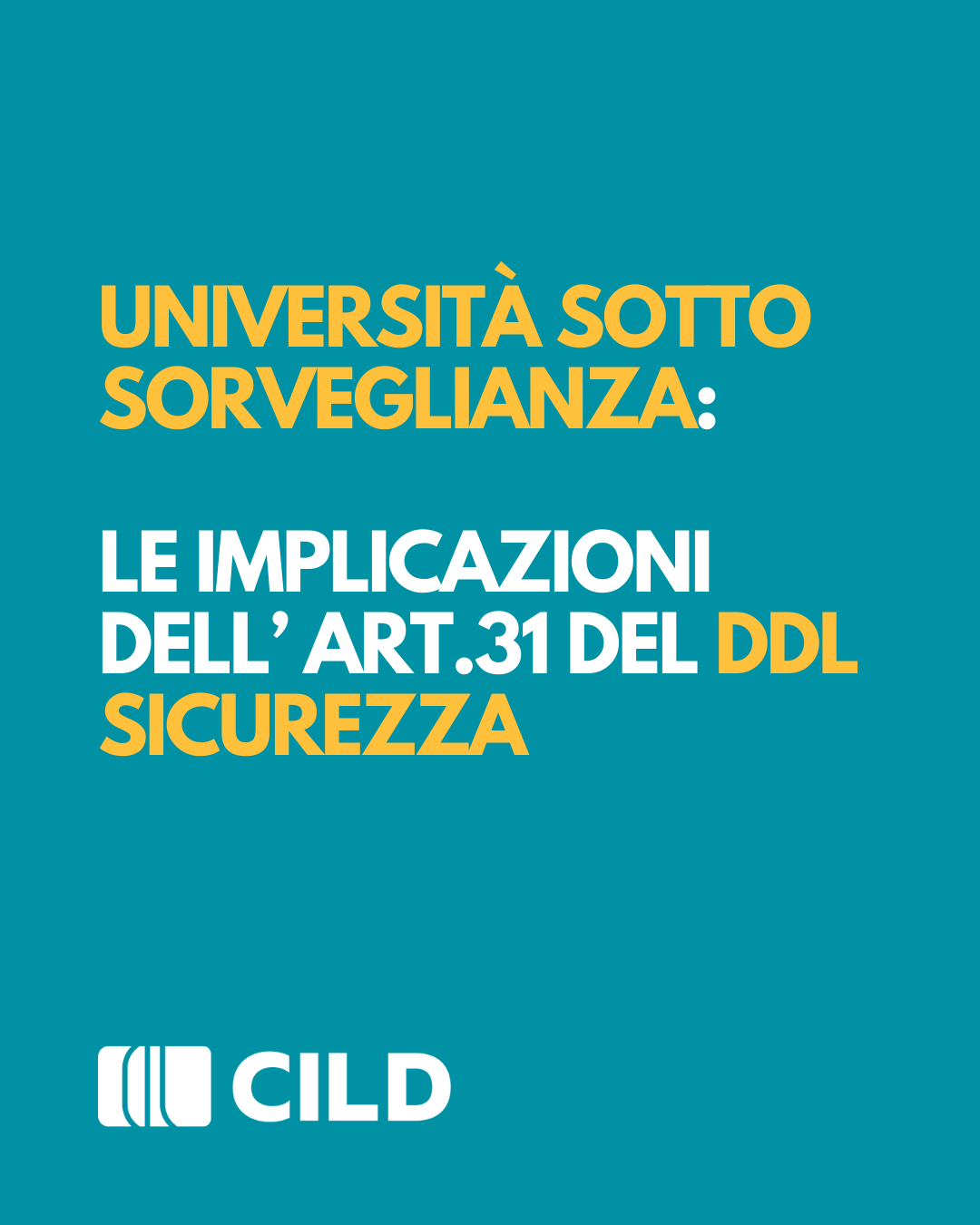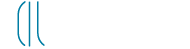Università sotto sorveglianza: implicazioni dell’art.31 del Ddl sicurezza
Di Marco Biondi
Il ddl 16/60, presentato il 22 gennaio 2024 e approvato dalla Camera a settembre 2024, è stato definito dall’associazione Antigone “il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana”. Oltre a introdurre 30 nuovi reati, aggravanti e ampliamenti di pena, imposta una logica di sicurezza basata solamente su proibizioni, punizioni e repressione del dissenso pacifico, superando anche i diritti alla privacy e veicolando l’idea che le manifestazioni di protesta siano un fatto da biasimare.
Tra le varie libertà sotto attacco del decreto sicurezza c’è anche quella accademica. L’articolo 31 del ddl disegnato dal ministro dell’Interno Piantedosi prevede infatti che “le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti a prestare al Dis, all’Aise e all’Aisi collaborazione e assistenza necessarie per la tutela della sicurezza nazionale”. Inoltre, i servizi segreti “possono stipulare convenzioni con questi soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza”.
Facendo un esempio pratico di cosa comporta questo decreto, se uno studente o un docente partecipano a un determinato movimento politico, o a un’associazione attivista, l’Università dovrà comunicarlo su richiesta dei Servizi. Allo stesso modo ci si dovrà comportare se un professore insegna in aula tesi ritenute “pericolose” o sovversive.
Come scrive Luciana Cimino sul Manifesto, “l’articolo in questione mira a modificare la legge del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza. Ma se quel testo disciplinava che «il Dis, l’Aise e l’Aisi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano (…) servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali», la nuova formulazione del governo Meloni cambia l’ordine dei soggetti e il verbo, modificando in peggio la collaborazione tra organi dello Stato e università”.
La differenza con il passato, come spiegato da La legge per tutti, “sta nel fatto che prima questi organi di tutela della sicurezza nazionale potevano chiedere informazioni riservate agli Atenei sugli studenti iscritti, nonché sui docenti, ma le Università potevano opporre i motivi di privacy (e anche l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali era intervenuta più volte per limitare queste richieste di accesso”.
Giustificando questo disegno di legge con la necessità di sicurezza, il pericolo tangibile è quello di trasformare rettori e organismi di ricerca in informatori segreti, schedando ricercatori e studenti. Questa misura antepone la “sicurezza nazionale” alla protezione di dati sensibili come possono essere le opinioni politiche e l’orientamento sessuale. Oltre alle università, questo meccanismo va ad impattare tutte le Pubbliche Amministrazioni e permetterà agli organi investigativi, attraverso apposite convenzioni, di accedere alle banche dati e ai fascicoli informatizzati che contengono le informazioni sul personale dipendente o sugli studenti iscritti alle Università. Per questa ragione gli Enti Pubblici o le Università non potranno opporre “il diniego a fornire le informazioni in base alla normativa sulla riservatezza dei dati personali, neppure quando si tratta di dati sensibili, la cui divulgazione o diffusione altrimenti costituirebbe reato”.
Come scritto da Giuseppe Gagliano per InsideOver, “l’assenza di filtri e garanzie procedurali nelle modalità di accesso dei servizi alle banche dati aumenta il rischio di violazioni della privacy e crea una zona grigia in cui il controllo democratico e la trasparenza risulterebbero limitati, favorendo una concentrazione di potere senza un efficace meccanismo di responsabilità”.
Gli organismi di tutela della sicurezza nazionale legittimati ad ottenere informazioni personali sono: il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), l’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e l’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna).
“L’obbligo di collaborazione con i servizi segreti limita la libertà delle università e degli enti di ricerca di operare in modo indipendente, rischiando di coinvolgerli in dinamiche estranee alla loro missione istituzionale” dichiara il Comitato per la Libertà Accademica della Società per gli studi sul Medio Oriente (SeSaMO).
Secondo Elisa Frigeni, senatrice accademica di UniMi intervistata da vdnews, questa norma, come altre disegnate dal governo Meloni, è molto vaga e potrebbe interessare tutti gli studenti che esprimono un pensiero critico con l’obiettivo di reprimere un ambiente, quello universitario, limitando la capacità di portare avanti le proprie idee.
L’Aisa ha definito questa misura un “attacco diretto” all’autonomia delle università e un passo verso una forma di controllo che minaccerebbe le libertà fondamentali. A dar man forte a questa denuncia si sono uniti i sindacati, con la segretaria della Flc Cgil, Gianna Fracassi, che ha dichiarato: “In gioco ci sono libertà tutelate dalla Costituzione, come la libera espressione e la tutela della riservatezza”.
Il 17 gennaio l’Unione degli Universitari ha organizzato un presidio a Roma contro il provvedimento, definito un “Grande Fratello” pronto a invadere le aule universitarie.
Il decreto sicurezza, approvato alla Camera il 18 settembre 2024, attende il sì definitivo da parte del Senato e l’entrata in vigore, che avverrà con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che il presidente della Repubblica non opponga rilievi di incostituzionalità rifiutandosi di porre la propria firma sul decreto, rinviando ad un nuovo esame delle Camere.