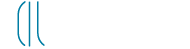Carcere di Santa Maria Capua Vetere. La violenza e il ruolo della polizia
di Patrizio Gonnella
Le immagini di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ci devono costringere a fare delle riflessioni intorno al ruolo delle Polizie in uno Stato democratico, al culto della violenza, alle tecniche di prevenzione. In premessa va detto che il tema è complesso. E’ necessaria una sorta di conversione antropologica che metta al centro la persona. Sarà utopico ma è l’unica prospettiva capace di tenere le comunità in equilibrio. I corpi di Polizia devono essere i luoghi per eccellenza della legalità. Devono esserlo a tutti i costi. Sono titolari di un potere sulle persone. Questo è sacrosanto in una democrazia. Devono però gestirlo con l’obiettivo di ridurre il tasso globale di violenza. E sulla prevenzione della tortura è necessario soffermarsi. Quando si parla di tortura è essenziale distinguere tra società democratiche e società non democratiche. In queste ultime la tortura è esplicitamente rivendicata o comunque è parte di un sistema di compressione su larga scala delle libertà, in primo luogo quelle di opinione e di dissenso. La tortura, insieme alla detenzione arbitraria e alle sparizioni forzate, è lo strumento ordinario utilizzato dalle forze di sicurezza o dai gruppi para-militari per evitare destabilizzazioni al regime imposto. Nei regimi totalitari tortura e negazione dei diritti politici sono i tasselli di un mosaico violento costruito dal potere politico per perpetrare nel tempo se stesso senza andare incontro a rivolgimenti. Dunque, nell’Italia di Mussolini, nel Cile di Pinochet o in una qualunque delle teocrazie contemporanee la tortura è servente rispetto alla preservazione o al consolidamento del potere. La battaglia contro la tortura è parte della battaglia contro il regime ed è del tutto irrilevante se la tortura è legalmente consentita o formalmente bandita. Nelle democrazie costituzionali, invece, la prevenzione della tortura è una delle vie per evitare la tracimazione verso l’autoritarismo illiberale.
La tortura finanche in uno Stato di diritto non è mai qualcosa che avviene inaspettatamente. È più o meno sempre possibile intuire che potrebbe accadere in un luogo piuttosto che in un altro. Un episodio di tortura non giunge mai inatteso. Nelle democrazie accade che di fronte a fatti gravi qualificati dall’opinione pubblica e riscontrati dalla magistratura come tortura, le istituzioni si difendono avvalendosi della teoria delle mele marce. I responsabili vengono definiti quali schegge impazzite e criminali, eccezioni dunque rispetto all’ordinarietà di un sistema repressivo che viceversa si muoverebbe costantemente nel solco della legalità. La teoria delle mele marce però si sgretola ogniqualvolta i diversi livelli istituzionali coinvolti non hanno erto muri normativi, operativi e culturali a difesa dell’habeas corpus. Lo Stato che non anestetizza i rischi di tortura attraverso vie legali e operative diventa correo dei torturatori i quali non possono essere più qualificabili in modo semplificato mele marce sfuggite a una professionalità legalmente esercitata. Dunque in primo luogo la tortura deve essere punita. E deve esserlo assicurando tempi di prescrizione del reato che garantiscano chance adeguate di giustizia. I processi per casi di questo genere sono difficili, lunghi. Richiedono indagini meticolose che rompano il muro dell’omertà. In molte storie di tortura mancano i testimoni. La paura di ritorsioni della persona torturata ritarda la denuncia e di conseguenza l’avvio delle indagini, rendendo le prove mediche evanescenti. Nei casi di violenza dei custodi nei confronti delle persone custodite la denuncia deve potere essere presentata alla fine del periodo di reclusione legale. Ciò significa che l’emersione degli episodi dall’oscuro di un carcere potrebbe avvenire anche anni o decenni dopo le violenze o le minacce subite. Lo Stato che, attraverso la tagliola della prescrizione, non lo consente diventa corresponsabile dell’impunità del torturatore.
In una democrazia che funziona la prevenzione passa non solo dalle norme ma anche dai comportamenti e dalle azioni degli attori pubblici. Le autorità competenti, di fronte a episodi di tortura, devono avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei presunti responsabili senza attendere gli esiti lunghi dei processi penali. La prescrizione giudiziaria non deve mai essere in sede disciplinare posta a fondamento di un provvedimento di assoluzione nel procedimento disciplinare con relativa permanenza in servizio del funzionario accusato di tortura ma salvato dalla durata del procedimento. Il torturatore deve essere stigmatizzato davanti ai suoi colleghi. La tortura, qualora non perseguita dal proprio corpo di appartenenza, diventa occasione di vanto galvanizzata dalla certezza dell’impunità nonché della conservazione del posto e del luogo di lavoro. Uno Stato che non separa il presunto torturatore dal torturato, senza penalizzare quest’ultimo, è correo del delitto. Era il 2001 quando dieci, fra agenti di polizia penitenziaria e operatori sanitari, vennero indagati a Potenza per i maltrattamenti inferti a un detenuto tunisino. L’inchiesta era cominciata il 3 agosto del 2000, quando un giovane tunisino di ventun’anni era salito sui tetti del carcere per protestare contro le percosse subite il giorno prima. Un consulente nominato dal PM accertò la compatibilità delle lesioni riportate dal detenuto con i maltrattamenti denunciati. Le ipotesi di reato contestate erano lesioni gravi e gravissime, falsa certificazione medica. Il giovane tunisino si suicidò il 17 aprile 2001. Per alcuni mesi rimase nello stesso carcere e con le stesse guardie che lui aveva denunciato. Torturatore e torturato devono essere divisi, fisicamente ma anche processualmente. Accade nelle storie di violenza che il pubblico ufficiale accusato di atti di tortura denunci l’accusatore per calunnia. Non vanno mai unificati i processi per le violenze con quello per calunnia nei confronti della persona che ha sporto denuncia. E’ questa una cattiva prassi giudiziaria che disincentiva le azioni giudiziarie e riduce il tasso di fiducia nei confronti della giustizia. L’unificazione dei procedimenti rende indistinguibili vittime e carnefici. Mettere sullo stesso piano processuale tortura e calunnia significa derubricare la tortura a qualcosa di molto meno grave, avente un ben diverso tasso di offensività penale.
La tortura si nutre di spirito di corpo il quale non è altro che la costruzione di un’identità comune violenta e machista. Uno Stato potrà essere deresponsabilizzato rispetto al singolo episodio di tortura, legittimamente minimizzato a circostanza eccezionale prodotta da una mela marcia, solo se ha la forza morale di anteporre la dignità del singolo individuo all’identità collettiva del corpo di polizia. Lo spirito di corpo verrebbe palesemente messo in discussione dalle seguenti azioni istituzionali:
- adozione di un codice etico di condotta degli appartenenti alle forze di polizia e sicurezza come quello suggerito dall’Onu, ovvero una sorta di codice di Ippocrate all’interno del quale sia esplicitamente proibita la tortura e ogni forma di trattamento disumano o degradante nonché siano valorizzati comportamenti virtuosi in termini di promozione dei diritti umani;
- istituzione presso le Procure di sezioni specializzate in fatti di tortura e violenza. Nelle indagini va utilizzato personale appartenente ai diversi copri di polizia il quale sia a sua volta adeguatamente e specificatamente formato anche con nozioni di etica professionale, medicina legale e psicologia. In molti uffici giudiziari operano pool di giudici specializzati nel contrasto dei reati dei colletti bianchi. Corruzione e tortura fanno parte di uno stesso campo semantico. In ambedue i casi è determinante che a commettere il crimine sia un funzionario pubblico il quale nel momento in cui lo compie sta agendo in nome e per conto dello Stato. La tortura e la corruzione sono entrambi parte dei cosiddetti reati dei potenti. Così come per la corruzione, per sconfiggere le violenze istituzionali sarebbe opportuno specializzare procuratori e poliziotti, anche per evitare che si produca quel cortocircuito investigativo tante volte osservato nei casi giudiziari. Non è raro che vi siano inquirenti timorosi di indagare nei confronti del personale di polizia sapendo che nel futuro avrà bisogno di quegli stessi agenti per altre inchieste penali;
- tutela dei testimoni che hanno il coraggio di raccontare quanto visto. Vanno applicate le stesse regole dei testimoni di giustizia nei processi di mafia. I rischi a cui vanno incontro sono comparabili. Se i testimoni sono a loro volta detenuti vanno protetti in luoghi del tutto sicuri dove non entrino mai in contatto con le persone sotto accusa. Qualora il testimone sia un agente delle forze dell’ordine, va garantito nelle prospettive di carriera;
- indicazione all’Avvocatura dello Stato di costituirsi parte civile ogniqualvolta si giunga a dibattimento per fatti di violenza commessi da parte di operatori delle forze di sicurezza. Se così fosse il messaggio pubblico sarebbe eloquente in quanto lo Stato dichiarerebbe esplicitamente in un processo che ha deciso di schierarsi dalla parte delle vittime degli abusi, sottraendo le mele marce alla difesa pregiudiziale da parte del corpo di appartenenza;
- interruzione di ogni relazione sindacale con quelle organizzazioni che offrono tutela legale a coloro i quali si macchiano di crimini di questo genere. I sindacati delle forze di polizia sono in alcuni casi una retroguardia culturale che alimenta lo spirito di corpo. Viceversa vanno previsti incoraggiamenti, anche economici, per quei poliziotti che interpretano in modo ‘legale’ il loro ruolo;
- riconoscimento dell’identità di ognuno dei poliziotti o agenti di sicurezza coinvolti in azioni di ordine pubblico. Si tratta di un’azione che non necessita di una iniziativa legislativa e che riporterebbe l’atto di violenza alla sua responsabilità individuale. In mancanza di un numero o un nome che identifichi il poliziotto, la colpa è di tutti. Di fatto l’assenza di numeri identificativi fa sì che vinca lo spirito di corpo, melmoso e omertoso;
- cambiamento profondo nell’iconografia del lavoro delle polizie, ovvero utilizzazione di un vestiario e di un portamento personale che non rimandino a un’idea di uso greve e collettivo della violenza. In pratica significa dismissione di tute mimetiche e di tenute da sommossa, nonché rinuncia a sguardi truci oscurati da occhiali da sole impenetrabili i quali impediscono a carnefice e vittima di guardarsi reciprocamente negli occhi;
- organizzazione di momenti alti di formazione sui diritti umani a favore del personale di polizia con compiti di sicurezza pubblica. Va decostruito lo spirito di corpo a partire dalla formazione di una diversa e comune coscienza umanocentrica;
- video-sorveglianza che consenta di avere sotto controllo tutti i luoghi del carcere.