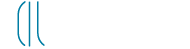Le narrazioni che il governo vuole cambiare e il ruolo della Rai
Negli ultimi mesi si è discusso molto di Rai, di libertà di informazione, di pluralismo dei media.
Lo si è fatto a partire da alcuni abbandoni di illustri professionisti che ormai da molti anni lavoravano nel servizio pubblico radiotelevisivo: Fabio Fazio, Corrado Augias, Lucia Annunziata, Amadeus.
Lo si è fatto a proposito di casi di censura, come quello che ha riguardato lo scrittore Antonio Scurati.
Lo si è fatto, con le proteste dei giornalisti Rai, rispetto agli spazi garantiti all’esecutivo senza vincoli e senza intermediazioni giornalistiche.
In tutti questi casi si è riproposto il tema del controllo che la politica esercita sulla Rai, un controllo in parte aumentato negli ultimi anni. Prima con la Riforma Renzi del 2015, che ha ridotto da 9 a 7 i membri del Consiglio di Amministrazione (Cda), riducendo così la rappresentanza (ma garantendo comunque alla maggioranza di governo ampi poteri di nomina), ma soprattutto attraverso l’istituzione del ruolo dell’Amministratore Delegato che, indicato dal governo e nominato dal cda, ha poteri di nomina di direttori di rete, testata, canale e dirigenti di seconda fascia. Un potere su cui il Cda esprime solo un parere (obbligatorio ma non vincolante, salvo per i direttori di testata nel caso i contrari alla nomina siano i 2/3). Poi con il cambiamento del finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo che, anche con la legge di bilancio 2024, ha portato ad una riduzione del canone, ma ad un prelievo deciso dal governo sulla fiscalità generale che, per i prossimi tre anni, sarà di circa 400 milioni l’anno. E, quindi, ad una dipendenza più stretta dall’esecutivo anche per il finanziamento, oltre che per le nomine.
Una serie di disposizioni, quelle che attualmente regolano la Rai, che sono in aperto e ampio contrasto con quelle previste nel Media Freedom Act, recentemente approvato in Europa e che, di fatto, dovrebbe portare a riformare il servizio pubblico anche in Italia. Come, sarà la vera sfida aperta dei prossimi mesi e anni.
Una sfida che dovrebbe partire innanzitutto da un quesito non tecnico: nel 2024, che senso ha e che ruolo deve avere il servizio pubblico radiotelevisivo?
Osservando ciò che è accaduto in Rai da quando l’attuale governo è stato eletto, quello che sembra evidenziarsi è il tentativo di utilizzare la tv di Stato per cambiare la narrazione complessiva del Paese. In un’ottica molto poco aziendalista o economicista, il rinunciare ai professionisti cui si faceva riferimento all’inizio, ha portato ad una perdita di audience e dunque di introiti pubblicitari. Solo pochi giorni fa Il Sole 24 Ore ha riportato come “In prima serata (la fascia nobile, anche per gli investimenti pubblicitari), svuotata di importanti punti di forza Rai 3 perde tra una stagione e l’altra il 19,8% del proprio pubblico e registra il peggior calo d’ascolto di tutte le reti”. Ma non solo nella fascia “prime time” perde ascoltatori Rai 3 che, riporta sempre il giornale di confindustria, registra una perdita di oltre 277 mila spettatori quotidiani.
Dati da cui sembrerebbe emergere un disinteresse per le performance che ogni azienda dovrebbe perseguire, ma un approccio invece volto ad eliminare – o ridimensionare (come nel caso del programma “Che sarà” di Serena Bortone, dove scoppiò il caso Scurati, portato da due a un solo giorno) – voci non in linea con la nuova narrazione.
Tornando al caso Scurati, ci sono diversi elementi di gravità attorno a quanto accaduto. Il primo è senz’altro la censura, arrivata solo poche ore prima della messa in onda. Il secondo è stato l’intervento diretto della Presidente del Consiglio Meloni, che ha in qualche modo accusato lo scrittore di pretendere cifre altissime (1.800 €) per pochi minuti di monologo (dimenticando che però che un monologo di pochi minuti porta con sé ore di scrittura e ancor prima mesi di studio e ricerche). Ma un aspetto probabilmente centrale era l’oggetto del monologo, che diventa quasi un caso-studio rispetto a quelle che possono essere gli approcci del governo sulle narrazioni: il 25 Aprile come festa antifascista.
Che molti dei membri dell’attuale esecutivo non abbiano, per ragioni di provenienza storica, politica e ideologica, mai digerito fino in fondo la narrazione attorno alla Festa della Liberazione è evidente, essendo stato anche più volte dichiarato.
Il 25 Aprile, l’antifascismo, sono valori condivisi dal paese che hanno pesato e – anche se forse meno – continuano a pesare perché richiamano in sé altri valori: quelli sanciti dalla Repubblica e della Costituzione, entrambe nate sull’onda lunga della lotta di Liberazione a cui parteciparono molti dei futuri costituenti, fossero democristiani, socialisti, comunisti, azionisti, liberali. Un tavolo dai quali furono esclusi i post-fascisti che, per tutta la Prima Repubblica, epoca storica in cui molti esponenti del governo sono cresciuti politicamente, vennero tenuti ai margini, forti di quei richiami storici.
Lotta di Liberazione, difesa della Repubblica e della Costituzione che ancora oggi sono elementi valoriali forti, che hanno sempre funzionato, dinanzi a tentativi di stravolgimento dell’apparato statale, laddove i referendum confermativi delle modifiche costituzionali hanno posto un blocco alle stesse e che probabilmente saranno richiamati anche nel caso di un referendum confermativo della riforma presidenzialista cui il governo sta lavorando.
Dunque lo stop al monologo di Antonio Scurati si può leggere nel tentativo di cambiare la narrazione sul 25 Aprile, facendolo innanzitutto diventare un terreno di scontro.
Non più una giornata di unità nazionale, ma una ricorrenza di una parte contro un’altra. Polarizzare i sentimenti attorno a questa data, sganciandoli dalla storia comune del Paese (che richiamano valori cari anche all’elettorato di destra, come quelli della Patria e della Nazione) e ancorandoli invece alla propria preferenza politica del momento.
Hans Hansen, nel suo libro “Narrative Change. How changing the story can transform society, business, and ourselves”, scrive che “le narrazioni sono un prodotto della nostra sensibilità collettiva. Quando produciamo una narrazione, generiamo alcune visioni del mondo. Se le narrazioni diventano ampiamente condivise in una cultura, stabiliscono presupposti particolari su come dovrebbero essere le cose, presupponendo logiche di causa-effetto che conducono a un finale carico di valore. Oltre a definire come dovrebbero essere fatte le cose, le narrazioni esistenti servono come schema interpretativo che usiamo per dare un senso agli eventi quotidiani. […] Usiamo le narrazioni per definire la situazione – se l’evento è positivo o negativo nel nostro futuro – quindi utilizziamo altre narrazioni per guidare le nostre decisioni su cosa fare”.
Jonathan Gottschall, dal canto suo, sottolinea come “Tutta l’instancabile comunicazione che effettuiamo nel corso della nostra vita ha uno scopo prioritario: quello di influenzare le menti di altre persone, di spingere in una certa direzione il modo in cui pensano, percepiscono e in ultimo si comportano. Ogni volta che comunichiamo, usiamo parole vuote e inconsistenti per suggestionarci a vicenda, per alterare l’opinione altrui, anche se soltanto di poco, riorganizzando così il mondo a nostro favore”.
Che proprio riorganizzare il mondo a proprio favore possa essere uno degli obiettivi del governo è lecito pensarlo ed è proprio per questo e per quanto detto finora che il dibattito sulla Rai non può essere solo un dibattito tecnico, di meccanismi di nomina per garantire una maggiore indipendenza delle reti, di finanziamento.
Ma occorre discutere di narrazioni o quali sono quelle che la televisione pubblica deve portare avanti per raccontare il paese e la sua storia. E che società queste narrazioni devono costruire.