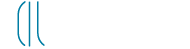Migranti in Grecia: tra detenzione e violazione dei diritti umani.
Per comprendere quelle che sono le condizioni delle persone migranti trattenute nei Pre-Removal Detention Centers (PRDCs) e nei Controlled Access Centers (CCACs) in Grecia abbiamo intervistato la ONG Equal Rights Beyond Borders, organizzazione fondata nel 2016 che fornisce assistenza legale gratuita a persone migranti e richiedenti asilo in Grecia, Germania e nell’UE. Riportiamo di seguito quanto emerso dalle domande poste a seguito dell’evento “European conference on the monitoring of conditions in administrative detention centres for migrant people”.
1. Qual è il quadro legislativo che regola la detenzione amministrativa nel Paese? (durata massima della detenzione, condizioni e servizi minimi, gestione pubblica o privata, processo di convalida della detenzione, ecc.).
La detenzione avviene nei Pre-Removal Detention Centers (PRDCs), è gestita dalla Direzione della Polizia Ellenica – Ministero della Protezione del Cittadino – e attualmente sono operativi 7 PRDC in tutta la Grecia, uno dei quali si trova alle frontiere dell’Egeo (Isola di Kos).
- La detenzione dei richiedenti la cui procedura di asilo è in corso è disciplinata dalla legge sull’asilo 4939/2022, che recepisce la direttiva UE 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza. Secondo la legge, i richiedenti asilo non dovrebbero essere detenuti per il solo motivo di aver presentato domanda di protezione internazionale o di essere entrati nel paese in modo irregolare e/o di rimanere nel paese senza un permesso di soggiorno legale. La detenzione dei richiedenti asilo può essere imposta solo per motivi specifici previsti dalla legge, tra cui l’identificazione degli elementi relativi all’identità/origine/nazionalità del richiedente, la determinazione degli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e richiede l’emissione di ordini di detenzione pienamente motivati da parte della polizia. Il periodo massimo di detenzione dei richiedenti asilo è di 18 mesi.
- La detenzione amministrativa per motivi di rimpatrio dei richiedenti asilo respinti è disciplinata dalla legge 3907/2011 che recepisce la direttiva sul rimpatrio 2008/115/UE ed è imposta ai richiedenti asilo respinti ai fini della loro riammissione in Turchia o del loro rimpatrio nel paese di origine/provenienza e la sua durata, secondo la legge, è anch’essa di massimo 18 mesi, senza prospettive realistiche di rimpatrio. Gli standard minimi per le condizioni di detenzione sono stabiliti dalla legislazione nazionale e dall’UE e comprendono il diritto all’assistenza legale, l’accesso all’assistenza sanitaria e condizioni di vita umane. In pratica, tuttavia, molti PRDC hanno segnalato nelle loro relazioni che tali standard non possono essere rispettati in un PRDC.
Per quanto riguarda l’isola di Kos, si segnala indicativamente la mancanza di personale medico o di salute mentale all’interno del PRDC dal 2021, la mancanza di interpreti e, in generale, le condizioni di vita deplorevoli, poiché la struttura è totalmente trascurata. Il sovraffollamento è un altro problema che affligge altri PRDC in tutta la Grecia. Nel complesso, le condizioni di detenzione nei PRDC rimangono al di sotto degli standard, nonostante alcune buone pratiche adottate in alcuni PRDC (come la possibilità per i detenuti di utilizzare i propri telefoni cellulari). Tra le principali preoccupazioni figurano la struttura carceraria, simile a una prigione, la mancanza di igiene e di articoli non alimentari, compresi vestiti e scarpe, materassi e coperte puliti, la mancanza di attività ricreative e il sovraffollamento che persiste in alcune strutture.
La revisione giudiziaria della detenzione è prevista dalla legge, ma per i richiedenti asilo è spesso attuata in modo formalistico e non individualizzato. Per coloro la cui domanda è stata respinta, la legge prevede la revisione giudiziaria del provvedimento di detenzione ogni tre mesi, ma ciò non avviene quasi mai.
Altri tipi di detenzione:
1. Detenzione di fatto dei richiedenti asilo nei cosiddetti Controlled Access Centers (CCACs) gestiti dal Ministero della Migrazione e dell’Asilo:
- Al loro ingresso in un CCAC, i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sono sottoposti a una restrizione della libertà ai fini delle procedure di accoglienza e identificazione, con una decisione emessa dal direttore del campo entro 5 giorni. La legge prevede in via eccezionale la proroga di tale restrizione fino a un massimo di 25 giorni in totale e solo per motivi procedurali (completamento delle procedure di accoglienza e identificazione).
- I richiedenti asilo sono molto spesso confinati oltre i 5 giorni iniziali (a volte anche per mesi a causa dell’elevato numero di arrivi), senza il diritto di uscire dalla struttura. In alcuni casi, i richiedenti sono privati della loro libertà senza essere stati informati di alcuna decisione di detenzione, vivendo in condizioni inadeguate.
2. Detenzione di fatto dei Minori Non Accompagnati e separati nelle cosiddette “aree sicure” dei CCAC:
- All’arrivo nei CCAC, i MSNA vengono collocati in “zone sicure” all’interno delle strutture, designate come aree “protette”. Il direttore del CCAC emette una decisione di privazione della libertà di 5 giorni che non viene mai comunicata ai minori. I minori rimangono praticamente detenuti nella zona sicura per periodi di tempo indefiniti senza che venga emesso un ordine di proroga della detenzione, in attesa dell’assegnazione di un tutore e del loro trasferimento in adeguati centri di accoglienza per minori.
2. Le organizzazioni della società civile e le ONG hanno accesso a queste strutture? Quali sono gli ostacoli che ne impediscono l’accesso?
In generale, l’accesso ai CCAC è consentito agli avvocati (ad eccezione delle zone sicure), ma è soggetto a severe restrizioni: la visita deve avvenire per motivi specifici, scortati dalle guardie di sicurezza, non è consentito l’accesso alle aree di residenza dei rifugiati e spesso le autorità negano l’accesso agli interpreti che non sono ufficialmente certificati dalle autorità statali. Per quanto riguarda l’accesso ai centri di detenzione pre-espulsione gestiti dalla polizia, l’ingresso degli avvocati è generalmente concesso dopo che una richiesta di accesso è stata inviata al segretariato locale del PRDC, in cui sono indicati il numero di matricola della polizia/i dati personali del detenuto e una data/ora specifica in cui avrà luogo l’incontro con il potenziale cliente. La polizia crea molto spesso ostacoli all’ingresso di colleghi e interpreti internazionali non greci (controlli casuali di effetti personali ecc.). La presenza della polizia è spesso piuttosto intensa durante gli incontri con i clienti.
3. Se avete accesso alle strutture per monitorare le attività, quali sono gli elementi che osservate/indagate? (igiene, cibo, servizi sanitari, accesso all’assistenza legale, nazionalità della popolazione, composizione del personale, ecc.) Utilizzate mai il FOIA (Freedom Of Information Act) per accedere alle informazioni sui centri? Che tipo di violazioni dei diritti umani emergono dalle vostre attività di monitoraggio?
Quando viene concesso l’accesso nei PRDC, gli avv ocati possono incontrare le persone solo in una stanza/ufficio specifico designato dalla polizia e, in alcuni PRDC, anche presso le recinzioni della sezione esterna. Finora, non è stato concesso alcun accesso alle sezioni in cui vivono le persone. L’unica informazione che otteniamo sulle condizioni è quella che ricaviamo dalle interviste dirette ai detenuti. Pertanto, oltre alla fornitura di assistenza legale, tali interviste includono tipicamente l’osservazione di:
- Condizioni igieniche e sanitarie.
- Qualità e quantità del cibo.
- Accesso all’assistenza sanitaria e identificazione delle vulnerabilità.
- Fornitura di informazioni legali e accesso all’assistenza legale.
- Pratiche disciplinari e uso dell’isolamento.
Il monitoraggio rivela spesso:
- Detenzione prolungata, soprattutto per le persone vulnerabili.
- Mancato accesso alle procedure legali o assistenza legale insufficiente.
- Assistenza sanitaria e psicosociale inadeguata.
- Condizioni materiali precarie e attenzione insufficiente alla dignità e alle esigenze individuali, maltrattamenti, confisca dei beni.
Abbiamo richiesto l’accesso ai dati alle autorità e al Ministero (numero di rimpatri e dati demografici della popolazione rimpatriata). Tuttavia, le risposte sono spesso ritardate e/o incomplete.
4. Oltre alle attività di monitoraggio, svolgete anche altri tipi di interventi all’interno dei centri?
- Assistenza legale e rappresentanza nella procedura di asilo.
- Contestazione della detenzione illegale dinanzi ai Tribunali amministrativi competenti.
- Presentazione di reclami al’Ombudsman greco greco per richiedere interventi.
- Presentazione di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo in merito alla detenzione illegale quando non vi sono prospettive realistiche di rimpatrio.
- Rinvio ad attori esterni (se questa opzione esiste a seconda del luogo) come professionisti medici per l’accesso delle persone a servizi sanitari adeguati.
- Interventi presso le autorità di polizia per il rilascio di persone con problemi di salute e richieste di sospensione del loro allontanamento.
5. Cosa succede alle persone una volta che lasciano i centri di detenzione amministrativa?
La mancanza di un sostegno strutturato al reinserimento o alla transizione è una lacuna critica nel quadro di protezione. Al momento del rilascio, le persone possono:
- Ottenere lo status di rifugiato ed essere rilasciate (se sono in procedura di asilo), senza però essere accettate in un altro campo “aperto”.
- Coloro che sono detenuti in vista del rimpatrio vengono rilasciati al termine del periodo di detenzione totale e di solito hanno a disposizione 25 giorni di tempo per lasciare il Paese di propria iniziativa. Questa pratica porta la persona in un limbo giuridico senza accesso ad alloggi o servizi e la espone al rischio di una nuova detenzione nel caso in cui venga arrestata sul territorio greco dopo la scadenza del suddetto termine.
6. In che misura le informazioni sulle condizioni all’interno dei centri di detenzione raggiungono l’opinione pubblica attraverso i media mainstream? Esistono movimenti di grassroots che fanno eco alle preoccupazioni sulle condizioni e le esperienze che provengono dall’interno?
La copertura mediatica mainstream delle condizioni di detenzione è limitata e spesso influenzata da narrazioni securitarie o xenofobe. Occasionalmente vengono pubblicati reportage investigativi, ma non raggiungono sempre un vasto pubblico. D’altra parte, le reti della società civile sul terreno hanno svolto un ruolo essenziale nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso testimonianze dirette dei detenuti. Pubblichiamo anche rapporti annuali sulle condizioni all’interno del centro di detenzione pre-espulsione di Kos e anche all’interno delle “aree sicure” dell’UAM delle isole di Kos e Leros. Vengono monitorate anche le condizioni di vita all’interno dei CCAC delle isole di Kos e Leros (anche sulla base della nostra operatività in queste due isole dell’Egeo).
7. In che modo il sistema dei campi e degli hotspot si inserisce nel modo in cui vengono gestiti i fermi e i respingimenti dei migranti, anche alla luce delle continue segnalazioni di violazioni sistematiche dei diritti umani? In che modo le stazioni di polizia vengono strumentalizzate a questo scopo?
L’approccio degli hotspot, introdotto inizialmente a livello UE nel 2015, è stato fondamentale per la strategia di gestione delle frontiere e della migrazione della Grecia, in particolare nelle isole dell’Egeo. Esso è stato reso operativo attraverso la creazione di Closed Controlled Access Centers (CCACs), come già menzionato sopra, che fungono sia da strutture di accoglienza che di detenzione, in molti casi senza una chiara distinzione giuridica tra questi due regimi e che, in generale, normalizzano la detenzione senza un accesso limitato ai rimedi giuridici e la totale mancanza di valutazioni individualizzate.
Inoltre, la pratica diffusa dei respingimenti comporta spesso la detenzione non ufficiale nelle stazioni di polizia o in altre strutture informali. La normalizzazione dei respingimenti è la narrazione dei richiedenti asilo. Dopo il naufragio di Pylos, le denunce per respingimenti sono diminuite, ma senza dubbio continuano a verificarsi regolarmente, poiché le denunce per respingimenti continuano. Dall’estate 2024 sono aumentati gli episodi di violenza alle frontiere che hanno causato morti e feriti gravi.
In sintesi, l’interazione tra il sistema degli hotspot, la detenzione amministrativa e l’uso strumentale delle strutture di polizia rivela un modello sistematico di violazioni dei diritti e di deterrenza istituzionalizzata. Piuttosto che essere eccezionali, queste pratiche riflettono un orientamento politico più ampio che privilegia il controllo della migrazione rispetto agli obblighi giuridici derivanti dal diritto dell’UE, dalla giurisprudenza della CEDU e dal diritto internazionale in materia di rifugiati e diritti umani.