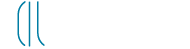5 domande a Giuseppe Campesi sulla detenzione amministrativa
Giuseppe Campesi è professore associato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari ed è coordinatore del Master in Criminalità e Politiche per la sicurezza. La sua ricerca si concentra su, tra gli altri temi, teoria sociale contemporanea, studi critici del diritto, politiche migratorie e per la sicurezza. Abbiamo rivolto cinque domande a Campesi in merito alla detenzione amministrativa e al rapporto pubblicato con Actionaid, “Trattenuti”.
1. In passato, in diversi contributi lei ha suddiviso la storia della detenzione amministrativa in Italia in quattro “grandi stagioni”: istituzionalizzazione (1998-2010), consolidamento (2011-2012), crisi (2013-2014) e reinvenzione (2015 in poi). Cosa emerge dal rapporto “Trattenuti” rispetto alle più recenti riforme legislative in materia? Siamo dinanzi ad una nuova “fase” della detenzione amministrativa?
La mia impressione è che la detenzione amministrativa in Italia stia ancora attraversando una complessa fase di reinvenzione. Mi spiego: quando suggerì per la prima volta che stavamo assistendo ad un tentativo di reinvenzione della detenzione amministrativa nel nostro paese intendevo dire che uno strumento originariamente creato per gestire la politica di rimpatrio stava progressivamente cambiando pelle, diventando un dispositivo cruciale per il governo della mobilità in ingresso attraverso le frontiere meridionali. Questo non significa che i centri di detenzione non saranno più utilizzati per custodire le persone in attesa di rimpatrio, ma l’impressione è che essi finiranno per avere un ruolo sempre più centrale nel trattenimento (preferibilmente nei pressi delle zone di sbarco) delle persone appena giunte sul territorio italiano, in particolare richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri. Continueremo ad avere strutture detentive nelle grandi aree metropolitane, chiamate a custodire persone intercettate in condizione di irregolarità sul territorio o provenienti dal carcere, ma le strutture situate nei pressi dei luoghi di sbarco acquisteranno sempre più centralità, trattenendo un numero più significativo di persone. Le radici di tale trasformazione sono essenzialmente due, mi pare: da un lato un dato strutturale, che ha che fare con il fatto che l’Italia sia meno attrattiva come paese di destinazione di quanto non fosse tra fine anni Novanta e primo decennio dei Duemila, essendosi progressivamente trasformata in un paese prevalentemente di transito; dall’altro una cornice politica mutata, in cui il tema del controllo dei movimenti secondari all’interno dello spazio Schengen ha assunto una centralità inedita, portando infine all’approvazione del nuovo Patto europeo su migrazioni e asilo, dove com’è noto la detenzione nelle zone di frontiera di alcune categorie di richiedenti asilo è addirittura un obbligo dei paesi membri. Nonostante ciò, continuo a ritenere che la fase di reinvenzione non si sia chiusa perché non è detto che il disegno tracciato con il Patto europeo su migrazioni e asilo, che in qualche modo l’Italia sta cercando di anticipare, sia facile da implementare. Questo sia per ragioni materiali, dato lo sforzo finanziario e infrastrutturale che imporrebbe ai paesi membri, che per ragioni giuridiche, dato che esso appare a molti in chiara contraddizione con alcuni capisaldi del diritto d’asilo.
2. Dal DL 10 marzo 2023, n.20 (Decreto Cutro), fino al progetto di esternalizzazione delle procedure di asilo in Albania, si sta affermando in misura sempre più evidente la tendenza all’impiego della detenzione per la gestione delle domande di protezione internazionale. Che impatto può avere questa tendenza sul futuro del diritto di asilo in Italia e in Europa?
Come accennavo in precedenza, la mia impressione è che l’Italia abbia tratto spunto da alcune delle misure che erano incluse nel Patto europeo su migrazioni e asilo, giocando d’anticipo. Ciò è stato del resto esplicitamente rivendicato dal Ministro dell’Interno nelle varie occasioni in cui si è trovato a difendere pubblicamente la scellerata operazione albanese. Questa fuga in avanti dell’Italia, che addirittura implementa in anticipo alcune delle misure che entreranno in vigore solo nel 2026 a livello europeo, sta funzionando come una sorta di “crash test” per il nuovo Regolamento procedure 2024/1348, facendo emergere quelli che saranno alcuni dei nodi cruciali (ad esempio la questione dei paesi c.d. sicuri) attorno ai quali si giocherà uno scontro politico e giudiziario sulle nuove procedure d’asilo di frontiera, che come noto prevedono la detenzione obbligatoria dei richiedenti. Un punto cruciale su cui forse occorrerebbe riflettere più attentamente, è che tali misure siano state esplicitamente giustificate come uno strumento di deterrenza. L’idea è che assoggettando alcune categorie di richiedenti asilo a procedure caratterizzate da un elemento afflittivo come la detenzione obbligatoria, si possa disincentivare i supposti “falsi rifugiati” dal tentare la strada dell’ingresso irregolare con conseguente richiesta d’asilo. C’è un aspetto criminalizzante in tale logica che nel corso del dibattito che ha accompagnato l’approvazione del Patto europeo su migrazioni e asilo, e più di recente nelle polemiche che sono seguite all’operazione albanese del Governo italiano, è sovente emerso in maniera particolarmente cruda ed esplicita. Assegnare alla detenzione dei richiedenti asilo una finalità deterrente, oltre ad apparire potenzialmente in contraddizione con il principio di non-penalizzazione sancito dall’art. 31(1) della Convenzione di Ginevra, mi pare estremamente pericoloso e segna un ulteriore passo decisivo in direzione della progressiva erosione delle garanzie e delle tutele accordate ai richiedenti protezione, il cui status appare sempre più approssimarsi a quella dei migranti in condizioni di irregolarità, se non addirittura di soggetti più o meno esplicitamente criminalizzati.
3. Quali sono le principali criticità che emergono dal rapporto “Trattenuti” rispetto alla gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in Italia? E che cosa raccontano i dati sulla popolazione trattenuta rispetto alle diverse funzioni assolte dai vari CPR in Italia oggi?
Se dovessi sintetizzare ciò che emerge dal nostro rapporto focalizzandomi solo su due dati, menzionerei innanzitutto la condizione di assoluta ingestibilità delle strutture detentive per stranieri, testimoniata dagli esorbitanti costi di manutenzione straordinaria. Tali costi sono il riflesso della tensione che si respira all’interno di tali strutture. Una tensione alimentata dalle pessime condizioni di detenzione, dalla cattiva gestione, dalla carenza di servizi, ma anche dal profondo senso di ingiustizia percepito da chi si trova ristretto in condizioni detentive senza aver violato la legge penale, senza aver commesso alcun reato. Un altro dato che menzionerei è che i CPR hanno negli ultimi anni essenzialmente funzionato come anticamera per i “rimpatri accelerati” dei cittadini di nazionalità tunisina, le uniche persone che si riescono a rimpatriare dal nostro paese. Rispetto alla politica di rimpatrio, l’efficacia dei CPR è pressoché nulla, dato che solo il 10% delle persone che hanno ricevuto un ordine di allontanamento dal nostro territorio viene poi effettivamente allontanato passando da un CPR.
4. Una delle criticità che il rapporto mette in evidenza è quella dell’inefficienza della detenzione amministrativa come strumento di governo delle migrazioni: secondo lei nell’attuale contesto politico nazionale e internazionale è sufficiente porre l’accento sui costi e sul mancato funzionamento del sistema CPR? In particolare, non vi è il rischio che l’argomento dell’efficienza sia pericoloso, portando ad una selezione della popolazione da tenere in ragione dell’effettività del rimpatrio?
Inefficienza e illegittimità sono due facce della stessa medaglia. Dimostrare che i CPR non perseguono il loro scopo ufficiale serve a fare emergere le funzioni latenti dei CPR, o meglio a costringere i decisori politici ad esplicitare quelle che sono le funzioni latenti del sistema detentivo per stranieri. Ad esempio, a fronte di dati che inequivocabilmente mostrano la totale inefficacia dei CPR quali strumenti della politica di rimpatrio, oltre che i loro costi esorbitanti, noi vediamo affacciarsi in maniera più esplicita argomenti che provano a giustificare il ricorso alla detenzione amministrativa con il riferimento alla necessità di controllare persone considerate “socialmente pericolose”, ovvero disincentivare i potenziali “falsi rifugiati” dal provare ad entrare irregolarmente in Italia per chiedere asilo. Come in un gioco degli specchi, la detenzione amministrativa cambia natura e comincia ad essere presentata come uno strumento di difesa sociale, o addirittura un surrogato delle politiche criminali. A questo punto può essere posto un problema di legittimità anche sul piano del diritto positivo in duplice senso. In primo luogo, la privazione della libertà personale è legittima in base alla Direttiva rimpatri “soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento”. In secondo luogo, gli strumenti di difesa sociale nel nostro ordinamento sono altri e la loro utilizzazione è circondata da precise garanzie che non sono aggirabili utilizzando la scorciatoia del diritto dell’immigrazione. Se c’è un’esigenza di difesa sociale è al diritto penale che si deve fare appello.
5. Come si posiziona rispetto alla legittimità costituzionale della detenzione amministrativa? possiamo parlare, secondo lei, di un sistema “irriformabile”?
Sono assolutamente convinto che la detenzione amministrativa degli stranieri sia incostituzionale e che, dunque, vada abolita. Questo essenzialmente perché, com’è noto, l’art. 13 della nostra Costituzione consente all’autorità di pubblica sicurezza di incidere sulla libertà personale di una persona senza previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria solo in casi di necessità ed urgenza. Il disegno costituzionale sembrerebbe quello di ammettere un potere detentivo dell’autorità di polizia solo nella cornice del potere detentivo dell’autorità giudiziaria, al quale si sostituisce momentaneamente. Dato che all’autorità giudiziaria è concesso di limitare la libertà personale solo in presenza quantomeno di un indizio di reato, la concessione di un potere sulla libertà personale alla polizia fuori della cornice dei poteri di polizia giudiziaria pare assolutamente esorbitante. Mi pare in sostanza, che mutatis mutandis restino valide le considerazioni che Guido Corso faceva a proposito del c.d. “Fermo di polizia” nel 1979, vale a dire che la Costituzione «non consente di attribuire all’autorità di polizia un potere di fermo che sia legato a presupposti diversi da quelli posti a base dei poteri cautelari del giudice»
Foto copertina via PiuCulture/Creative Commons